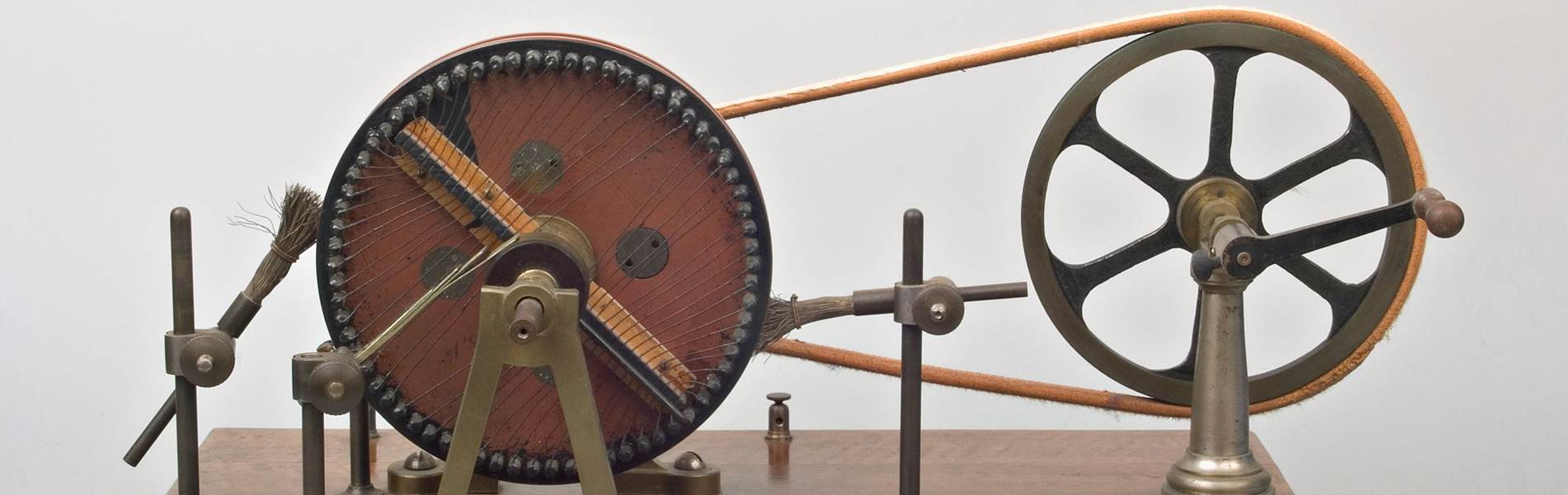le indagini diagnostiche hanno evidenziato evidenti lacune pittoriche e le mancanze del sottofondo gessoso, ripristinate durante i restauri che si sono susseguiti tra XVIII e XIX secolo.
Le vernici di finitura e i ritocchi pittorici della parte figurata delle due tavole si sono ossidati al punto da non rendere più visibile lo strato pittorico originario, alterandone sia i rapporti cromatici che quelli volumetrici. per meglio definire la metodologia della fase di pulitura (tecnica e materiali), sono stati eseguiti alcuni saggi sull'apparato figurativo con dimetilsolfossido, che ha favorito la rimozione delle vernici e dei ritocchi realizzati con acrilici dissolti in solvente. Questa tecnica di pulitura ha permesso di rimuovere esclusivamente le vernici sintetiche, preservando così gli interventi pittorici e le finiture dei restauri antichi, realizzate con tecniche tradizionali, che usavano olio di lino., Il dipinto versava in precarie condizioni di conservazione con notevoli sollevamenti e cadute di pigmento che sono stati la causa delle vaste e numerose ridipinture a tempera che lo caratterizzavano., L'opera, a causa di una condizione climatica non idonea e alla tipologia della struttura lignea, ha riportato una contrazione lignea che ha causato a livello di colore notevoli sollevamenti (anche molto importanti specialmente sul lato destro del dipinto) al limite della caduta., Il supporto ligneo è composto da n°6 tavole di pioppo innestate con cavicchi e incollate una all'altra. In seguito all'attacco aggressivo di insetti xilofagi il supporto ha subito numerosi interventi di restauro nel corso dei quali sono stati sovrapposti vari strati di materiali penetranti che hanno creato la fuoriuscita di tannino, rovinando e alterando molte zone di colore.
Nel corso dell'ultimo restauro il retro dell'opera è stato piallato dimezzando lo spessore per creare un supporto piano ed inserire n°3 traverse in senso orizzontale sostenute da tasselli incollati e avvitati.
La piallatura ha evidenziato le numerose gallerie di tarli e sedi di vecchie farfalle che sono state stuccate con un impasto di polvere di legno e colla animale, usato pure per la rasatura finale., L'opera è costituita da due tavolati in legno di pioppo di dimensioni diverse supportate da n°3 traverse avvitate. L'ambientazione climatica, con un tasso di umidità eccessivamente basso, ha favorito lo sviluppo di una fessurazione passante nella parte inferiore a sinistra del dipinto.
Per alleggerire le patine artificiali ottocentesche, si sono utilizzate tamponature con white spirit, che hanno rimosso parzialmente le patinature ad effetto spugnato e le finiture superficiali, riportando così in luce le originarie cromie e patine cinquecentesche degli incarnati. L’intervento sul fondo dorato si è limitato ad una leggera pulitura eseguita con spugne wishab per eliminare i depositi incoerenti di nerofumo.
La fase di consolidamento della pellicola pittorica e del sottofondo gessoso ha interessato prevalentemente i perimetri esterni delle due tavole, particolarmente instabili a causa della presenza del morbido strato, cosiddetto di sacrificio, in
polistirolo, interposto nei precedenti restauri tra il dipinto ed il supporto, per favorirne un eventuale futuro distacco dalla tavola in vetroresina. I perimetri sono stati rinforzati con una stuccatura a base di gesso di Bologna e colla organica,
perfettamente compatibili con i materiali utilizzati nel restauro precedente e totalmente reversibili in quanto stucchi di media durezza e facilmente asportabili meccanicamente.
Vista la presenza massiccia di stuccature antiche e moderne, ancora ben adese al supporto sottostante, si è deciso, per motivi conservativi, di non rimuoverle e di riutilizzarle come base per il nuovo ritocco pittorico, in quanto la rimozione e il
rifacimento di nuove stuccature avrebbero compromesso ulteriormente la superficie pittorica, in questo caso particolarmente abrasa ed impoverita. Sono state eseguite piccolissime stuccature nelle zone perimetrali del fondo oro in cui erano presenti delle piccole lacune.
Per questioni di compatibilità nei confronti dei materiali utilizzati precedentemente, si è proceduto a compiere una stuccatura eseguita con gesso marcio di Bologna e colla organica e rifinita con pelle di daino inumidita.
L’aggettante stuccatura in stucco oleoso di grandi dimensioni, presente in corrispondenza dell’albero nella tavola di San Sebastiano, è stata abbassata meccanicamente per essere portata al livello della superficie pittorica originaria.
La fase più complessa ed articolata è stata quella del ripristino pittorico delle lacune, riemerse in superficie dopo l’operazione di “derestauro”. La filosofia del restauro contemporaneo, impostato sulla riconoscibilità delle integrazioni pittoriche rispetto alla superficie originale, per la complessità dell’operazione ricostruttiva, ha portato ad effettuare più scelte metodologiche, che si sono associate alle esigenze dettate dalle specifiche tipologie pittoriche presenti nelle tavole, dalle diversità di tecniche e soprattutto dalle varie tipologie di degrado, antropico e naturale, presenti nelle due opere.
Per l’integrazione pittorica, è stata scelta la tecnica esecutiva delle vernici acriliche disciolte in acetato di butile, in quanto queste vernici presentano la caratteristica di essere più stabili rispetto alle integrazioni pittoriche realizzate con tempere ed acquerelli e, oltre a fornire buone prestazioni nella realizzazione del ritocco ad astrazione cromatica a pieno colore, garantiscono anche ottimi risultati per quanto riguarda il rinforzo cromatico in trasparenza sia del colore che delle ombreggiature e delle velature, con un risultato molto simile a quello dell’acquerello.
Le integrazioni per le parti originali e per le superfici iscurite da vecchi ritocchi pittorici irreversibili sono state suddivise in tre tipologie:
1. integrazioni a selezione cromatica imitativa con tecnica a puntinismo, con pennello n.0, per le parti figurate del paesaggio, per le vesti, per i capelli e per gli attributi dei santi: questa tecnica, infatti, si presta molto bene per integrare le lacune corrispondenti ad aree di pieno colore;
2. integrazioni a trasparenza cromatica imitativa con tecnica a rigatino, con pennello n.0, per gli incarnati. Questa tecnica risulta essere particolarmente adatta all’integrazione degli incarnati realizzati, come nel caso dei due dipinti, attraverso la tecnica della velatura e della sovrapposizione di ombreggiature trasparenti ad olio di lino, applicate sopra una base a tempera;
3. leggero rinforzo cromatico a campitura trasparente delle superfici dilavate e delle ombreggiature spatinate. Questa tecnica consente di equilibrare situazioni di estremo impoverimento e spatinatura delle superfici pittoriche, pur mantenendo a vista le parti originali ancora conservate.
Integrazioni pittoriche delle parti interessate da ricostruzioni storicizzate:
1. armonizzazione e riadattamento dei perimetri in rapporto alle parti pittoriche originali, emerse durante le fasi di pulitura, tramite la tecnica della selezione cromatica sottotono con tecnica a puntinismo con pennello n.0, come ad esempio la passamaneria della parte inferiore della veste e della sottoveste di Santa Caterina;
2. rielaborazione dei particolari della corda annodata sul tronco, dell’alluce del piede destro di San Sebastiano e del profilo del collo di Santa Caterina, tramite l’utilizzo degli ingrandimenti in rapporto 1:1, desunti dalle fotografie d’archivio di Luigi Ricci, in cui si evincono particolari andati perduti a partire dalla fine del XIX secolo, ancora sconosciuti durante le fasi di restauro ricostruttivo delle lacune eseguite prima da Bigoni all’inizio del ‘900 e poi da Caponi alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. Queste elaborazioni oggi sono state eseguite con selezione cromatica imitativa, con tecnica a puntinismo con pennello n.0. Le parti interessate da ritocco pittorico sono state trattate con vernicetta acrilica Lefranc&Bourgeois spray.
, Le cornici lignee sagomate sette-ottocentesche, rivestite in foglia d'argento e mecca e successivamente integrate nelle parti piani con porporina, sono state revisionate al fine di poter poi rimontare i due dipinti per l'esposizione negli ambienti museali.
Dopo lo smontaggio sono stati rimossi i depositi di polvere incoerenti con pennelli a setole morbide, sia sul retro che sul fronte delle cornici, che sono poi state pulite tramite tamponature di cotone idrofilo imbevuto con alcool bianco.
Sono stati eseguiti piccoli interventi di consolidamento che hanno consentito l'incollaggio (con resine viniliche) di alcune parti lignee distaccate sul retro della cornice di San Sebastiano.
Le vernici sono poi state trattate sul fronte con una vernice finale satinata, applicata a spruzzo, per uniformare le parti in foglia d'argento e mecca con quelle realizzate con porporina. La superficie lignea sul retro delle cornici è stata trattata con gommalacca decerata., Esaminando l'opera, partendo dall'alto, possiamo constatare con certezza che le braccia degli angeli sono state ricostruite, mentre le gambe erano ricoperte da nuvole in passato; il viso della Madonna è stato ritoccato per metà. tutto ciò è stato confermato dalle operazioni di pulitura con la rimozione delle vernici sovrastati e parte delle ridipinture. Pulendo il cielo attorno alla Santa è riemersa parte dei capelli e un ramo dell'albero che la affianca, elementi che erano stati occultati da una spessa velatura d'azzurro. La pulitura ha inoltre ridonato l'originale plasticità ai volumi delle vesti esaltando la leggibilità del leone di San Girolamo così come tanti piccoli particolari delle decorazioni del trono ormai offuscati da numerosi strati di vernici opacizzati e ingialliti.
Terminata la pulitura si è proceduto con la rimozione delle vecchie stuccature divenute instabili: durante questa fase sono emerse cospicue e profonde gallerie di insetti xilofagi ed un avanzato deterioramento della fibra lignea. Per questo è stato opportuno effettuare iniezioni di resina metacrilata per rinforzare il tavolato indebolito e colmare con pasta di legno i solchi provocati dall'avanzamento dei tarli. La stuccatura, effettuata con gesso di Bologna e colla animale, ha permesso di livellare le lacune, appianare i dislivelli e confondere l'unitura delle tavole.
Il ritocco pittorico è stato eseguito con una tecnica a puntini a sovrapposizione di colore e in parte a rigatino ed è risultato assai complesso nel massimo rispetto delle quasi intoccabili parti originali. L'intenzione è stata quella di non ricostruire ex novo ma di collegare in sottotono le piccole tracce di colore originale rinvenute con la pulitura, limitato l'uso del colore bianco per esaltare la tecnica e i colori usati dal Rondinelli.
Importante è stato il lavoro di pulitura dei volti e delle vesti dei protagonisti e quello sulle nuvole e il cielo.
La verniciatura finale protettiva anti U.V. ha concluso l'intervento., Trasferita in laboratorio la tavola è stata creata una camera di umidità controllata con umidificatore al fine di consentire una naturale distensione della fibra lignea e recuperare la planarità della superficie. Passati 15 giorni e verificata la stabilità del supporto ligneo, è stata eseguita la saldatura delle parti decoese con l'ausilio di iniezioni e imbibizioni di plextol B500 supportate da termocauterio e pesi.
Si è proseguito con l'eliminazione di vecchie piccole stuccature e riprese con nuove a base di gesso di Bologna e colla di coniglio. La parchettatura è stata revisionata per ottimizzare la stabilità della tavola. L'integrazione pittorica è stata eseguita con colori a vernice per restauro, l'applicazione di un sottile film anti-UV ha concluso l'intervento., L'intervento di restauro è iniziato con la rettifica della parchettatura, continuando poi con l'applicazione di impacchi di polpa di carta imbevuta di acqua calda al fine di ammorbidire le stuccature per poi rimuoverle con l'ausilio del bisturi. La rimozione delle vernici è avvenuta con carta assorbente e solvente facendo un lavaggio superficiale del supporto ligneo che ha evidenziato la venatura dei tavolati, la marezzature e i nodi; sono emerse alcune spaccature risanate con tasselli a cuneo di cm 5 e le sedi delle vecchie farfalle sono state colmate con legno della stessa essenza. La totalità della superficie lignea è stata consolidata con paraloid B72 al 20% in solvente volatile., La fessurazione passante nella parte inferiore a sinistra del dipinto, che era stata risanata con tassellatura della stessa essenza della fibra originale, di 5 cm di larghezza e angolatura di 30 °, è stata stuccata con gesso di Bologna e colla di coniglio. La stuccatura, rasata, è stata ritoccata con colori a vernice per il restauro e protetta da un sottile film di vernice anti-U.V.