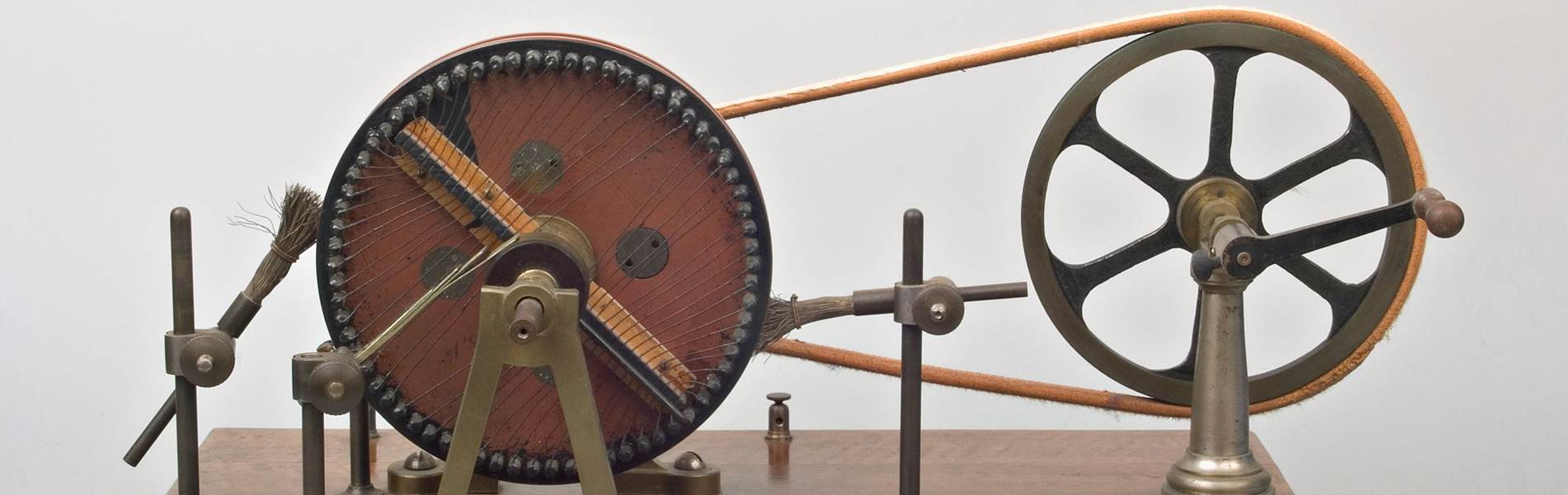Teatrino di San Salvatore
























posti 99
O. Mischiati, La prassi musicale presso i canonici regolari del SS. Salvatore nei secoli XVI e XVII, Roma 1985;
V. Maugeri, Note in margine ad alcuni affreschi “ritrovati” nel monastero di San Salvatore a Bologna, in “Strenna storica bolognese” 1994, p. 315-332;
M. Fornasari – M. Poli – A. Zaccanti, La chiesa e la biblioteca del SS. Salvatore in Bologna centro spirituale e luogo di cultura, Firenze 1995;
Un secolo, un libro “I ragazzi di via Volto Santo”. Centenario della Congregazione di Gesù Bambino fra gli studenti. Centro di orientamento culturale e spirituale SS. Salvatore. Bologna 1905-2005, Bologna 2005.
Via Volto Santo, 1
Bologna (BO)
Stando dunque al testo di Ricci la presenza di un teatro in questo complesso abbaziale avrebbe origini già nel XVII secolo ma attualmente mancano riferimenti documentari certi a conferma di quanto scrive lo storico. In compenso sappiamo che questo fu un prestigioso e importante luogo di cultura, dotato di una biblioteca di primaria importanza. Fu sede di un’importante scuola di musica e numerosi furono i compositori fra gli stessi canonici, ricordiamo tra gli altri Giovanni Maria Artusi 1546-1613, noto tra l’altro per essere stato in aperta polemica con Claudio Monteverdi.
Negli ambienti di questo antico complesso monastico, tra i più grandi e imponenti di Bologna, esiste tuttora un piccolo teatro: «un gioiello di serena compostezza, ricavato intorno al 1925 in quella che fu la Sala Capitolare» (Un secolo…, cit. p. 98). Nello stesso libro si racconta che in quel periodo vennero restituite dallo Stato ai religiosi due salette per l’interessamento del deputato poi Ministro degli Interni, Luigi Federzoni, e in quella più grande fu realizzato il teatro, inaugurato alla metà del giugno 1925. La prima messa in scena fu Il piccolo parigino di Angelo Pietro Berton (1861-1920), letterato attivo nel recupero e nell’educazione dell’infanzia.
Al teatrino si accede direttamente da via Volto Santo, attraversando uno dei tre chiostri rinascimentali, quello detto “del giardino” o “dei semplici”, adiacente alla chiesa e alla casa canonica e che, con il portico inferiore e loggiato superiore sui quattro lati, risulta essere il più ricco e completo. Chiostro che versa attualmente in pessimo stato conservativo. Al pianterreno del lato occidentale si accede sia agli ambienti che ospitano il Centro Culturale di S. Salvatore che a quelli che funzionano come atrio d’ingresso e “foyer” del teatrino. Più che evidenti sono le testimonianze delle antiche glorie dell’abbazia, l’atrio d’ingresso presenta fastosi stucchi sopra porte e rilevanti dipinti ad olio su muro di autori ignoti: due grandi ovali con scene bibliche racchiusi in cornici in stucco (sec. XVIII) che si fronteggiano sui lati lunghi: uno in particolare raffigura il Sacrificio di Isacco e un’Immacolata del XVII secolo di fronte all’ingresso.
All’interno del teatro sono tuttora presenti lacerti di affreschi cinquecenteschi (1545). L’ambiente, che era in origine la sala del Capitolo d’estate, presenta sulla parete a destra dell’entrata un Gesù nell’orto con gli apostoli e a parte due distinte figure di profeti: Isaia e Geremia, avvolte in ampi panneggi e impostate entro un finto vano architettonico. Della scena principale sono leggibili gli ‘apostoli dormiglioni’ in primo piano. La realizzazione del soffitto a cassettoni del teatrino ha tagliato la scena escludendo le lunette con le Sibille, angioletti e fregio ad arabeschi descritto dallo storico Trombelli. Grazie agli studi e ai restauri che hanno interessato gli affreschi possiamo affermare che sono riferibili al solo Biagio Pupini, escludendo l’intervento di Bartolomeo Ramenghi detto il Bagnacavallo, in quanto datati 1545 e a quella data il Bagnacavallo era già morto. In questo monastero il Pupini e il Bagnacavallo operarono insieme sia nel Refettorio che nella Biblioteca.
La sala teatrale è costituita dalla sola platea a pianta quadrangolare con un piccolo palcoscenico il cui boccascena rettangolare e strombato presenta una decorazione con festoni, nastri e strumenti musicali. il sipario è in velluto rosso damascato. Altri elementi di gusto eclettico sono presenti nelle decorazioni pittoriche delle travi e negli elementi del soffitto a cassettoni. Attorno al palco vi sono altri vani di servizio. Da testimonianze dirette sappiamo con certezza che questo teatro era attivo prima della Seconda Guerra Mondiale e la sala era la stessa di oggi. Nel periodo bellico l’attività del teatro si fermò per riprendere nel 1948 dopo averlo risistemato. Vi agivano i giovani della Stabile Filodrammatica del Centro culturale di S. Salvatore e fino al 1951 gli attori furono esclusivamente di sesso maschile per espresso divieto dell’abate ad ammettere donne in scena. La situazione si sbloccherà, grazie all’intervento della “Famiglia Bolognese”, in occasione delle rappresentazioni di Buona Pasqua, Giovannino il permaloso e L’arriva incu il 18 febbraio del 1951.
Attualmente il teatro è attivo e svolge una regolare stagione di prosa gestita da un gruppo teatrale.
(Lidia Bortolotti)