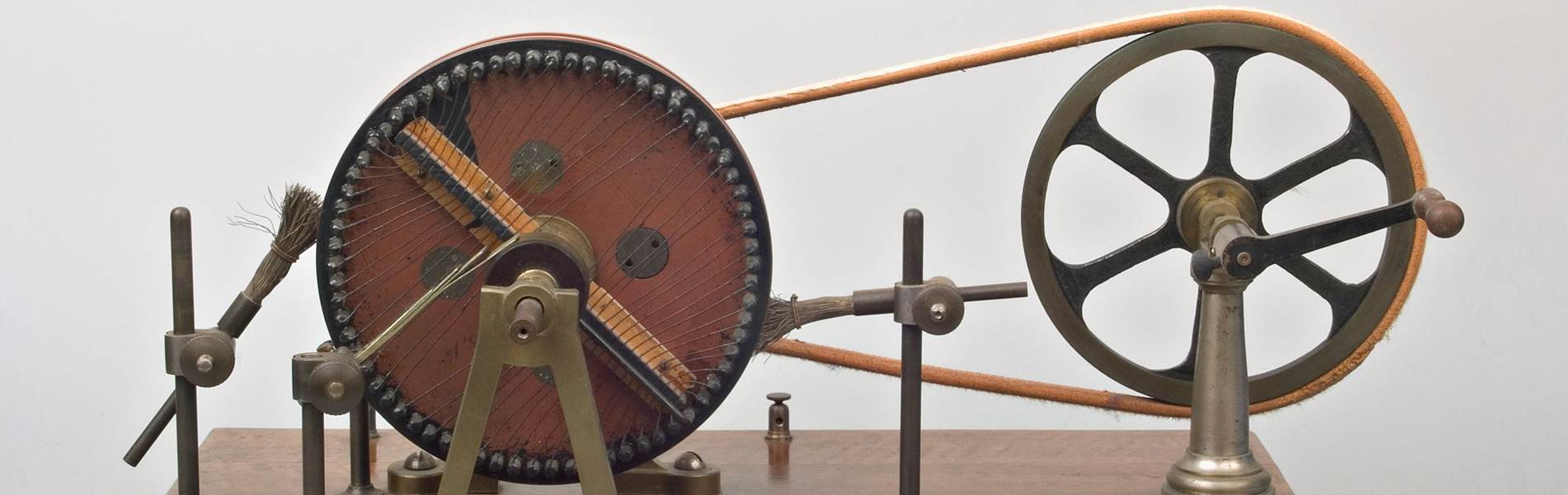mezzi di trasporto
ferro battitura
larghezza anteriore 150//larghezza posteriore 160
1909
usato per trasportare tutti i raccolti dei campi: sacchi di grano, fieno, cestoni di uva, letame, botti ecc.
Si aggiogava al timone del carro una coppia di buoi o mucche appositamente addestrate.
Il carro serviva anche per trasportare le masserizie del contadino quando si trasferiva in un altro podere.