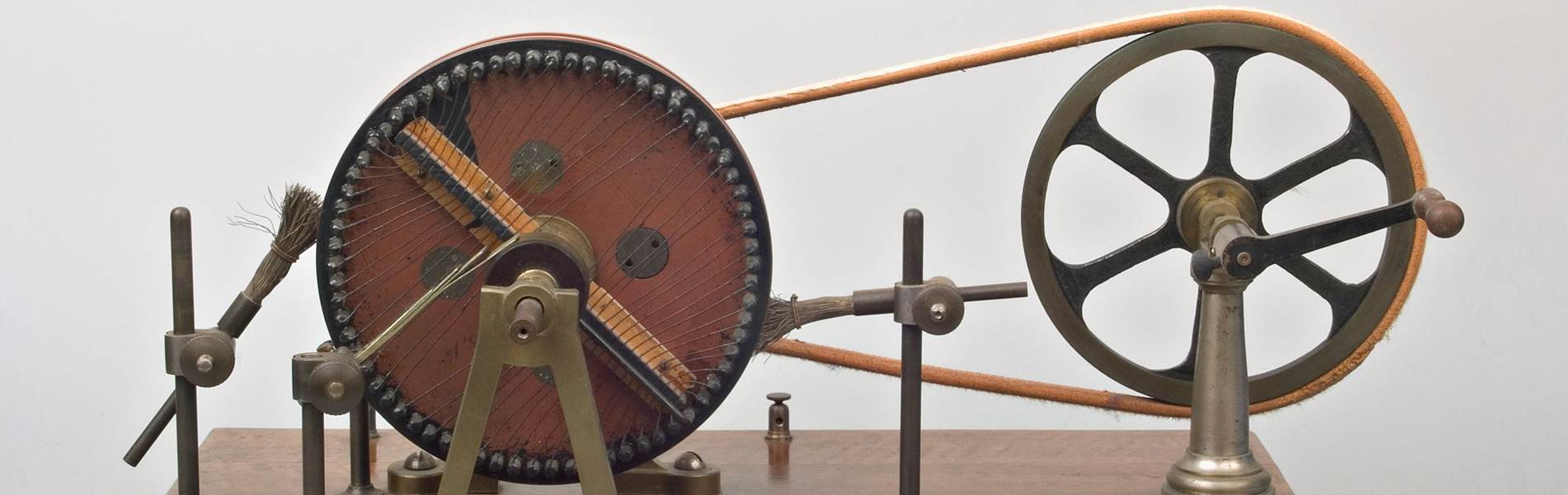tela/ pittura a olio
altezza con cornice 462//larghezza 282
sec. XVII (1631 - 1632)
Il Bellori (1672) scriveva a proposito di quest'opera: "Nel Duomo della città di Forlì nella tribuna della celebre cappella della Madonna del Fuoco, fra gli altri quadri di celebri maestri di mano d'Andrea [Sacchi] vi è la figura di San Pietro con un libro aperto nelle mani ed un angelo di sopra con le chiavi". Guarini (1847) riferisce che il dipinto fu poi trasferito nel 1838 presso l'Oratorio delle Orfanelle con il "Martirio di San Sebastiano" di Francesco Albani. Quindi entrambi nel 1851 furono collocati presso la Pinacoteca Comunale. Dopo l'identificazione da parte di Incisa della Rocchetta del ritratto n. 376 della Galleria Borghese di Roma (già attribuito a Orazio Giustiniani)- in Monsignore Clemente Merlini, forlivese, Auditore di Rota ed amico del Cardinale Antonio Barberini, Posse (1935) suggerì che Merlini potesse essere il committente del San Pietro del Duomo forlivese. Sacchi è autore di un altro San Pietro, conservato presso la Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma (Palazzo Barberini), molto simile alla versione di Forlì e dipinto certamente prima dell'aprile 1644 (cfr. Sutherland Harris, 1977). Clemente Merlini morì nel 1642. Posse in seguito a questi dati e a considerazioni stilistiche collocò il San Pietro di Forlì, intorno all'anno 1640. Riferisce Viroli (1980) che un più antico terminus ad quem è indicato dalla relazione su di una festa religiosa del 30 settembre 1636, in onore della Madonna del Fuoco. In quella circostanza il dipinto del Sacchi fu portato in processione dalla Confraternita di San Pietro dei Battuti Bigi (Bezzi, 1637). La Sutherland Harris rileva che a questa confraternita apparteneva anche il Cardinale Merlini e che è quasi certo che fu il committente dell'opera al Sacchi. La decisione di onorare la Madonna del fuoco in questo modo era stata presa solo alcuni giorni prima (Bezzi): è quindi praticamente certo, riferisce Viroli (1980), che il San Pietro di Sacchi era già a Forlì in questa data e non fu commissionato e dipinto per l'occasione come invece credette il Marchesi. Riferisce il Bezzi che la costruzione della cappella fu presa nel 1618, mentre la prima pietra fu posta nel luglio del 1619. Casali annota un'iscrizione del 1631 che ricorda il completamento della copertura di piombo della cupola, benché la cappella fosse adibita a culto dal 1626. Viroli conferma le ipotesi della Sutherland Harris: la Confraternita dei Battuti Bigi potrebbe avere commissionato questo dipinto nel 1631, o anche prima, se la dimensione del loro altare era già stata stabilita. Il Sacchi, inoltre, fra il 1630 e il 1635 eseguì molte opere contemporaneamente, ma non si conosce la sua attività dall'inverno del 1631 a quello successivo. Queste considerazioni e l'analisi stilistica suggeriscono queste date per l'esecuzione. Ancora, Viroli sottolinea come l'iconografia del quadro sia facilmente decifrabile, ma non consueta. San Pietro ha tutti gli attributi che lo caratterizzano: il mazzo di chiavi, la tiara papale, il gallo e la rete da pesca. Il portico davanti al quale si svolge la scena simboleggia la Chiesa che, con Pietro quale fondatore, sorge dalle rovine del Vecchio Testamento. L'iscrizione nel libro è tratta dalla sua seconda Epistola, I, 10 e forse fu scelta perchè particolarmente importante per la confraternita dei Battuti Bigi, un gruppo elemosiniere fondato in onore della Madonna del Fuoco per fare opere di bene. L'iscrizione greca alla base è tradotta "la parola degli apostoli, dovunque ardente" e deriva da uno scritto di Giovanni Crisostomo. E' difficile determinare il grado di influenza che Merlini ebbe nella realizzazione dell'opera. Un disegno del Sacchi, conservato a Dusseldorf, ritrae il santo che impugna le chiavi e suggerisce che l'artista fu libero di elabrare artisticamente i simboli.