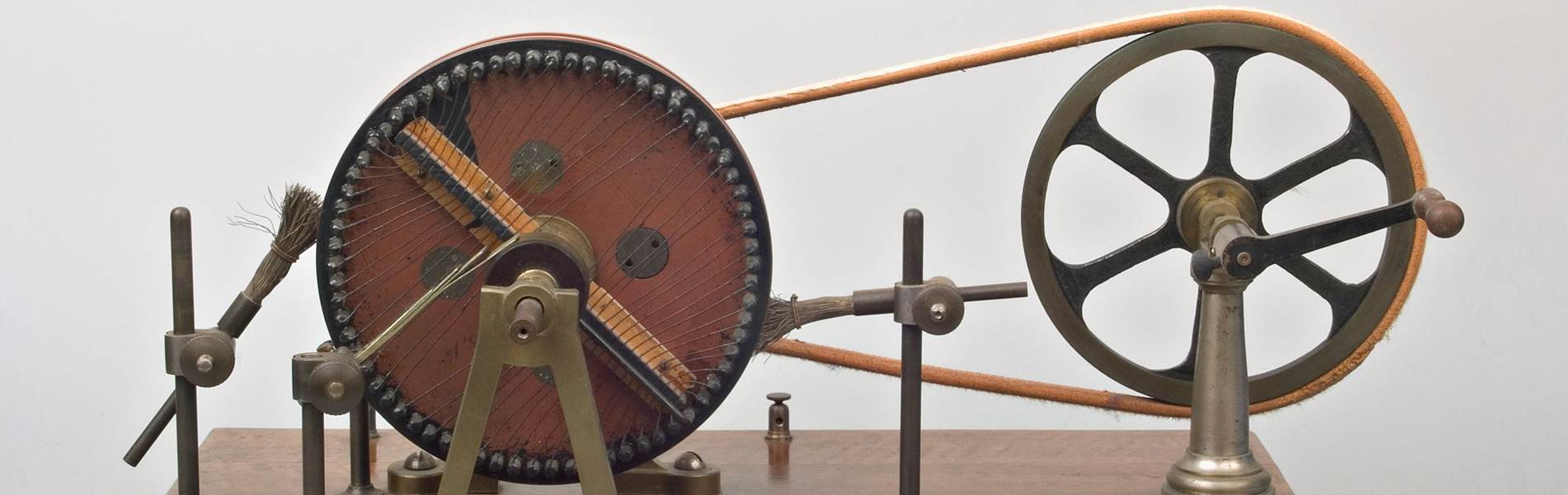tela/ pittura a olio
sec. XVII (1695 - 1696)
L’Avanzi raffigura pittoricamente questo episodio scandendolo in frammenti scenici disposti secondo una successione di quinte prospettiche, che sottendono momenti avvenuti in sequenze temporali diverse, riferiti alla nascita della storia certosina; le singole scene che creano il complesso puzzle narrativo, riprendono graficamente alcune incisioni di Theodor Krüger, tratte dai disegni di Giovanni Lanfranco, stampate nella "Vita del gran patriarca s. Bruno Cartusiano", di Meleagro Pentimalli del 1622, pubblicata propedeuticamente alla canonizzazione del Patriarca avvenuta nel 1623, e anche quelle ispirate dai disegni di Eustache Le Sueur, impresse da François Chauveau, in "La vie de St. Bruno, fondateur de l’ordre des Chartreux", edita nel 1660.
Iniziando la lettura dal lato sinistro, compare sulle nubi la figura della Beata Vergine col Bambino in grembo, nell’atto di porgere ad un certosino il libro delle “preci e lodi” mariane, che ha ai suoi fianchi, da un lato l’anziana figura di san Pietro con gli attributi iconografici che lo identificano quale Capo della Chiesa, dall’altro un giovane san Giovanni Battista semisdraiato che indirizza lo sguardo dello spettatore verso la scena sottostante che rappresenta il momento relativo all’individuazione del luogo dove verrà fondata la prima Certosa: fra un gruppo di cavalieri si
riconosce la figura di Bruno, connotata dal bianco saio certosino e in quella alla sua destra di sant’Ugo, vescovo di Grenoble, il primo patrono dell’Ordine. La scena allude al cammino intrapreso da Bruno e i suoi primi compagni, guidati da Ugo nel luogo già designato da Dio per la costruzione del primo insediamento eremitico, situato fra le impervie montagne della Chartreuse, evocato nel paesaggio al centro del dipinto. All’estremo lato destro della tela, l’artista dipinge in un piano più avanzato il cantiere della Grande Chartreuse e più in basso rappresenta le numerose maestranze che portano i materiali per l’avanzamento della costruzione; questa scena, che suggerisce il momento della nascita del primo eremo certosino, precede temporalmente il miracolo dell’Apparizione della Vergine, protagonista dell’intera rappresentazione.
In primo piano sono disposte le figure dei certosini che, smarriti, sono rappresentati già all’esterno dell’eremo che volevano abbandonare definitivamente ed è in questo momento che appaiono loro miracolosamente tra le nubi la Vergine e san Pietro. Tra i monaci, emerge la Maddalena, la peccatrice che attraverso il sacrificio dell’eremitaggio nel deserto ha aggiunto la redenzione dal peccato; con una mano indica al titubante gruppo la Vergine, la ‘santità’ cui essi aspirano e con l’altra addita sul terreno una pietra, sulla quale è inciso un lacerto grafico che ci riconduce al motto certosino O BEATA SOLITUDO O SOLA BEATITUDO. È nella SOLITUDO dell’eremo, nell’estraniarsi assoluto dalle voci del mondo ed ascoltando solo la voce divina che entra in lui, che il monaco certosino può̀ raggiungere Dio, la vera BEATITUDO.
In questa grande composizione corale, l’Avanzi esprime la sua abilità esecutiva in particolare nelle figure dei certosini in primo piano, espresse con forza materica, quasi scultorea, intrise di una luce che le connota quali protagoniste dell’episodio, creando nel contempo una scenografia dove le quinte prospettiche si rincorrono in una successione spaziale e temporale. L’emblematica figura del monaco in adorazione davanti alla croce esprime l’ideale spirituale di Bruno, ‘causa’ e ‘motore’ della fondazione di Chartreuse, che era il desiderio di raggiungere nel modo più alto possibile l’unione con Dio, attraverso la preghiera e la contemplazione mistica isolandosi dal mondo e dalle sue tentazioni.
La narrazione pittorica, che celebra la nascita dell’Ordine in Terra di Francia, collocata nel luogo più sacro e rappresentativo della liturgia certosina, ha dialogato per secoli con l’altra monumentale opera dell’Avanzi, posta difronte ad essa nel lato destro del presbiterio, nella quale l’Autore raccontando con sapiente maestria compositiva un episodio legato alle vicende del conte Ruggero d’Altavilla, evoca il radicarsi del pensiero cartusiano nelle Serre calabre, luogo dove Bruno fondò la prima Certosa italiana.
L’ "Apparizione della Beata Vergine" insieme all’ "Apparizione di San Bruno a Ruggero" vennero commissionate nel 1695 a Giuseppe Avanzi da dom Daniele Campanini, priore del cenacolo certosino ferrarese, e vennero collocate nell’aprile del 1696 sulle pareti del presbiterio della chiesa monastica. La commissione certosina, la data e il luogo preciso della collocazione dei dipinti in San Cristoforo, unitamente al consistente impegno finanziario per la loro realizzazione, sono testimoniati da Nicolò Baruffaldi: “Adì 22 detto (aprile 1696) Li Padri della Certosa esposero in publico nella Loro chiesa à latti dell’Altar Maggiore due gran Quadroni con sopra dipintivi alcune Opere di San Brunone per mano di Giuseppe Avvanzi Pittore Ferrarese in prezzo di scudi seicento senza l’azzuro, Tella, Tellaro e Cornici che in tutto costarono ottocento scudi d’ordine e spesa del P.D. Daniele Campanini priore del loro Monastero”.
Le due grandi tele sin dal momento della loro collocazione nel Sancta Sanctorum del tempio certosino, sono costantemente citate dagli storici e dai critici mettendo in risalto la maestosità delle loro dimensioni, ma non esprimendosi sulla loro qualità artistica, rimanendo piuttosto vaghi circa il titolo e il soggetto della tele, il più delle volte indicandoli genericamente come "Opere di san Brunone" o "Fatti di san Brunone"(vedi: Nicolò Baruffaldi, Giuseppe Antenore Scalabrini, Giuseppe Reggiani, Amalia Mezzetti - Emanuele Mattaliano, Patrizia Massarenti); quando ne vengono specificati i singoli titoli e i soggetti, si segnala una costante concordanza nella definizione di quelli relativi alla tela con l’episodio dell’ "Apparizione di san Bruno al conte Ruggero di Sicilia durante l’assedio di Capua" (che era collocato sulla parete destra del presbiterio della chiesa di San Cristoforo), mentre discordanti in quelli relativi all’episodio dell’ "Apparizione della Vergine e di San Pietro", che lo descrivono aggiungendo od omettendo la presenza di alcuni personaggi raffigurati nel composito scenario pittorico, creando equivoci sulle peculiarità visive afferenti ad un preciso e fondamentale episodio riferito alla nascita e al consolidamento della vicenda certosina, indubbiamente indicato all’artista al momento della commissione (vedi: Cesare Barotti, Giuseppe Avventi, Ippolito Andreasi, Gualtiero Medri, Carlo Ludovico Ragghianti, Eugenio Riccomini, Raffaella Montanari, Enrico Ghetti).
Dopo le testimonianze storiche (sopra citate) e documentarie (vedi Elisabetta Lopresti 2022) giunteci sino a metà del secolo scorso, nelle quali era indicata con continuità la presenza nel presbiterio delle grandi tele, non sono più segnalate all’interno della Chiesa e se ne erano perse le tracce sino al loro ‘ritrovamento’ attorno agli anni Duemila, reso possibile grazie al ‘certosino' lavoro di ricerca propedeutico al recupero di tutto il patrimonio artistico della Chiesa, condotto ad opera dei Musei Civici di Arte Antica di Ferrara. Il laborioso intervento di restauro sulla tela raffigurante l’ Apparizione della Vergine e di San Pietro, conclusosi nell’ottobre 2023, ha reso
nuovamente leggibili le immagini delle numerose e simultanee scene che compongono l’episodio, che l’Avanzi aveva eseguito con un fervore pittorico dai toni ‘eroici’, le quali ci portano ad individuare e a collocare storicamente “l’avvenimento miracoloso occorso in Gran Certosa” agli esordi della vicenda certosina, come accuratamente riportato dallo storico della ‘certosinità’ Benedetto Tromby, e a precisarne l’intitolazione come "Apparizione della Beata Vergine e San Pietro ai compagni di San Brunone esortandoli a tornare all’eremo della Gran Certosa" (come in: Daniele Campanini, Carlo Brisighella, Silvia Vecchi, Elisabetta Lopresti 2018 e 2022, Giuliana Marcolini).