Realizzate su carta ottocentesca, erano caratterizzate dall’avere tecniche grafiche e
problematiche conservative comuni.
Le problematiche osservate erano imputabili
principalmente a materiali, sistemi di montaggio e pregresse modalità conservative
non idonei; tali fattori hanno determinato gravi danni di natura sia chimica (degrado acido-ossidativo), sia fisica (danni di natura meccanica, come lacerazioni, deformazioni, abrasioni, ecc...), sia biologica (infezione microbiologica) compromettendo quasi totalmente la fruibilità e la leggibilità delle opere stesse.
Le opere erano inserite all’interno di tre registri composti da piatti in cartone rivestiti con carta “radica”, dorso in tela e sette nervi in canapa cinque dei quali passanti all’interno dei quadranti. Ogni tavola era ancorata al volume da un sistema di cerniere realizzate in tessuto e carta. Queste ultime avevano dimensioni sempre diverse in quanto dovevano regolarizzare il formato delle tavole - tutte diverse -all’interno del registro.
Le 48 tavole conservate all’interno dei registri n. 1 – 2 sono una sorta di collage
caratterizzato da una notevole varietà di supporti (sia di tipologia che di
grammatura). Composte da supporti ausiliari di tipo industriale di grande formato color marrone, le tavole sono costituite da una sequenza di documenti di diverse tipologie e dimensioni totalmente incollate a questi ultimi e spesso sovrapposte le une alle altre.
L’ipotesi che la composizione delle tavole non sia stata realizzata a caso è convalidata dalla presenza sul verso dei fogli di numeri progressivi eseguiti con matita blu, visibili in corrispondenza di alcuni distacchi, secondo una progettualità ben definita.
Dopo aver analizzato il materiale e individuato le problematiche principali, si è
proceduto con una preliminare micro - aspirazione di tutti i supporti e delle coperte
con micro - aspiratore Muntz. Successivamente si è intervenuto nella rimozione a secco delle fodere in tela del registro n. 3, durante tale operazione è stato di fondamentale importanza il rilievo grafico delle porzioni di supporto lacerate dall’attacco microbiologico al fine di poterle riapplicare nella giusta posizione in fase di restauro. La rimozione a secco dei depositi superficiali è stata eseguita – ove possibile - con polvere di gomma Staedtler, Wishab (sul verso) e spugne in lattice Smoke-Off Sponge, in grado di captare il particolato atmosferico senza impartire sollecitazioni meccaniche sulla superficie del supporto.
I trattamenti per via umida del vol. n. 3 sono stati precedentemente valutati tramite test preliminari di solubilità e di idrofilia, ottenuti depositando una goccia di solvente sia sulla superficie cartacea dell’opera che in corrispondenza dei media grafici.
Si è proceduto con la rimozione degli abbondanti depositi di colla presenti sul verso delle tavole del registro n. 3 dopo la sfoderatura eseguita a secco; per farlo si èscelto di procedere con addensanti a base acquosa (Tylose MH300P al 5% in acqua demineralizzata) in quanto rigonfiavano velocemente l’adesivo e favorivano una facile rimozione. Nelle parti contaminate dall’azione microbiologica invece,
l’adesivo era quasi totalmente inesistente ed era facilmente rimovibile con un
semplice trattamento disinfettante effettuato con una soluzione idroalcolica
composta da 70% di alcol e 30% di acqua applicata a tampone. La rimozione dei residui di scotch, dei depositi filmogeni di adesivo e delle macchie, in particolare quelle di ruggine, è stata eseguita ove possibile meccanicamente tramite bisturi.
Per le tavole foderate, del volume n. 2 – 3 invece, dopo un primo trattamento
disinfettante sul verso, le opere sono state collocate tra carte assorbenti di puro cotone ed un peso al fine di agevolare la spianatura dei supporti ausiliari deformati.
Le lacune e le lacerazioni sono state risarcite con veli e carte giapponesi selezionati secondo la texture superficiale, la grammatura e il grado di bianco dei supporti originali. Dopo aver tinto le carte con acquerelli Winsor&Newton e matite colorate, al fine di garantire un buon livello di uniformità tra restauro e l’originale, si è proceduto con il restauro vero e proprio. Il risarcimento è stato eseguito tramite
l’adesione lungo i margini della lacuna di uno o due strati di carta e velo giapponese mediante etere di cellulosa (Tylose MH 300 P al 5% in acqua demineralizzata ed in soluzione alcolica). Si è proceduto all’integrazione cromatica delle parti pittoriche e ad un ulteriore omogeneizzazione delle lacune mediante acquerelli Winsor&Newton e matite colorate.
Al termine dell’intervento, le opere hanno subito un ultimo trattamento disinfettante
mediante una vaporizzazione effettuata a spruzzo. Tale operazione è risultata
propedeutica allo spianamento.
RESTAURO DELLE COPERTE:
Le operazioni preliminari hanno previsto una microaspirazione dei biodeteriogeni
superficiali e delle polveri con microaspiratore museale della Muntz e successiva
disinfezione delle parti danneggiate con soluzione idroalcolica (70 alcol/ 30 alcol
etilico). Le operazioni di microaspirazione e disinfezione sono state effettuate una
prima volta quando i registri sono stati trasferiti in laboratorio, una seconda volta
dopo circa una settimana dal primo trattamento e ulteriormente reiterate durante le
operazioni di restauro. Questo ha permesso di disidratare le attività biopatogene ed
ha favorito una più facile rimozione meccanica delle spore presenti all’interno della
carta.
Le coperte sono state successivamente riconsolidate nelle parti cellulosiche con
Metil Cellulosa (Tylose MH300P al 5%), mentre le lacune sono state risarcite con
carte e veli giapponesi quali: Vang 517, Kami W12, Kami W8, Tengujo 3,7 g/m2.
Le parti in tessuto lacerate del dorso sono state semplicemente ricomposte con carta e Tylose MH 300 P al 5%. Le integrazioni cromatiche sono state eseguite con
acquerelli Winsor & Newton.





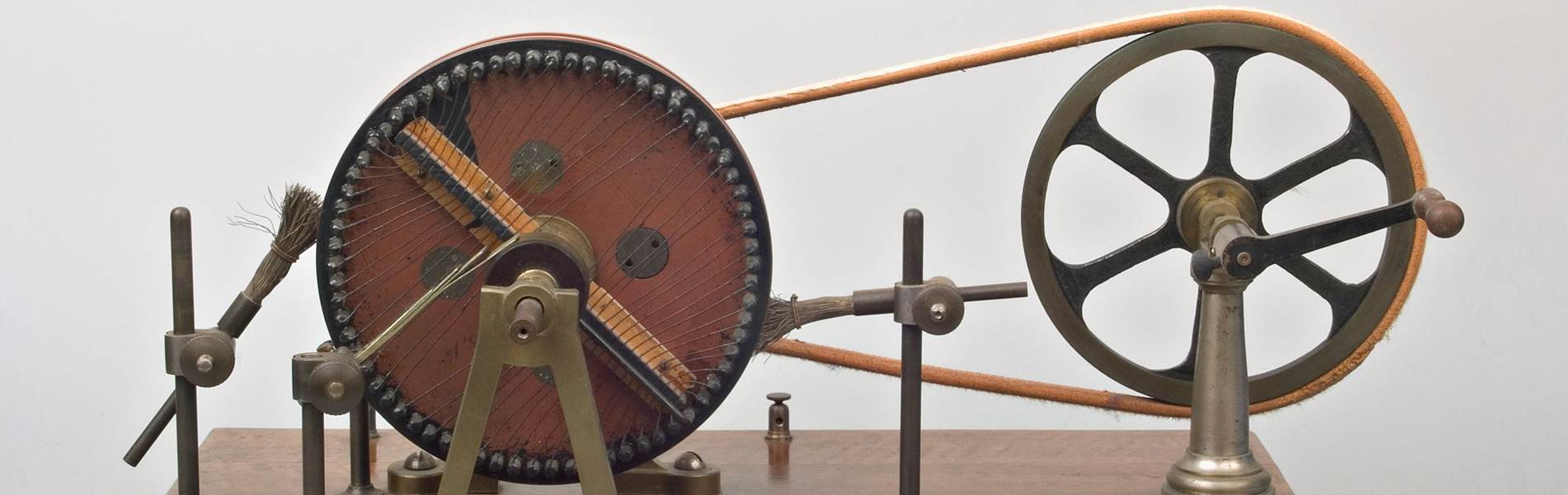




-med.jpg)
-med.jpg)
-med.jpg)
-med.jpg)
-med.jpg)


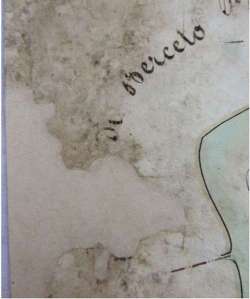
-sml.jpg)
-sml.jpg)
-sml.jpg)
-sml.jpg)
-sml.jpg)


