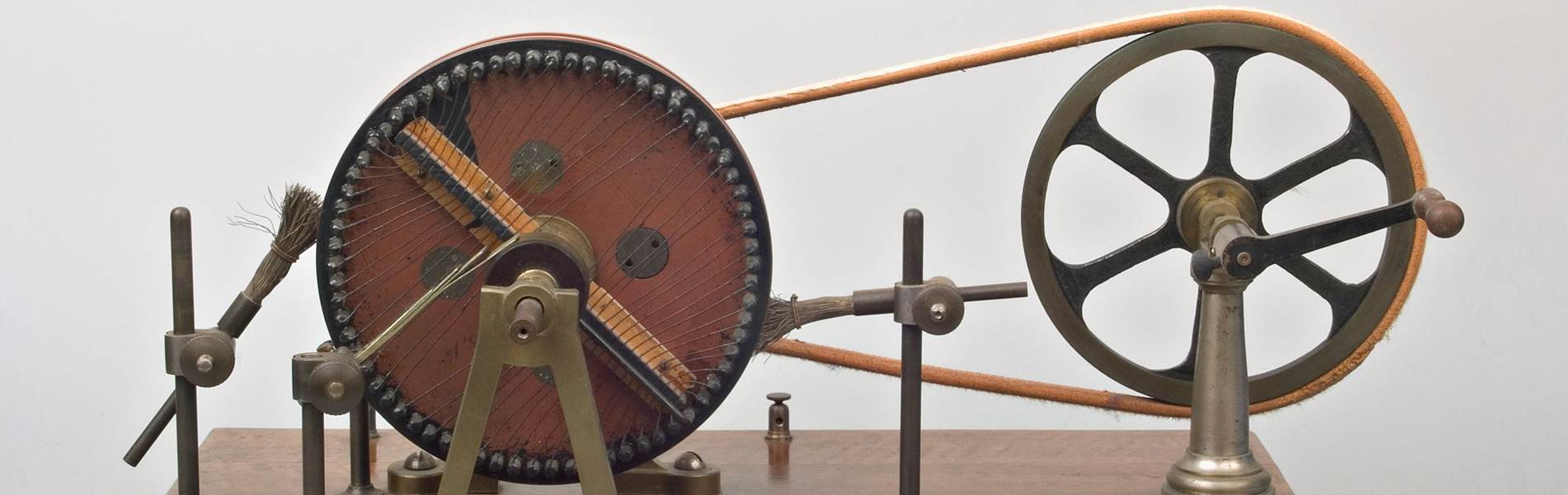offuscava la cromia originaria dei tessili e che nel tempo aveva determinato una forte disidratazione delle fibre, in particolare quelle seriche, che in alcuni casi si avvicinavano per consistenza ed aspetto a manufatti cartacei.
Nel caso di alcuni abiti femminili, caratterizzati da ampie gonne in taffetas di seta, si rilevavano numerosi tagli, lacune e lacerazioni estese. Alcuni elementi decorativi risultavano staccati e scuciti.
Erano stati realizzati nel tempo alcuni interventi manutentivi con filati incongrui e punti piuttosto grossolani, nel tentativo di evitare la perdita di materiale e il deterioramento di alcuni elementi.
Le uniformi in panno di lana apparivano interessate da rosure di tarma e abrasioni del “vello” che lasciavano a vista il fondo più chiaro del tessuto, senza il classico effetto di tridimensionalità del pannetto.
I filati metallici utilizzati per alcune finiture apparivano ossidati e scomposti; i bordi di polsi e le rifiniture di abiti e giacche in pizzo erano scuriti e deformati., La struttura lignea è in buone condizioni statiche. È composta da essenze differenti (abete, larice, pioppo, rovere). Per necessità di musealizzazione sono state incollate e inchiodate in verticale due stecche di larice con scanalatura sul retro delle colonne, in modo da poter inserire un vetro. In realtà
questa protezione era molto limitata, in quanto tutta la parte lignea dipinta rimaneva esposta alla possibilità di essere toccata dal pubblico. Inoltre, il vetro frangibile e oscillante nelle guide rappresenta un pericolo potenziale per i visitatori e per l’opera.
I depositi particellari erano cospicui, specie negli incavi degli incastri, sulla faccia superiore e sui fori delle cantinelle e all’interno del vano retrostante il palcoscenico.
Era presente rosume da insetti xilofagi, limitatamente agli elementi in abete e pioppo.
Le parti dipinte a tempera erano segnate da gore di acqua e da polvere di pece fusa, oltre a cadute di pellicola pittorica e abrasioni a causa antropica.
Il sipario, in tela di cotone apprettata e dipinta a tempera, era lacerato lungo il bordo superiore ed era stato incollato e inchiodato al bastone per le movimentazioni. Nel bordo inferiore era stato infilato un tondino di ferro, il cui peso ha causato la deformazione permanente della tela, che è libera sui lati e priva di cimosa. La superficie dipinta era frammentata in scaglie; inoltre erano ampiamente diffuse pieghe e abrasioni, con conseguente perdita di colore. Le lacerazioni erano risolte con toppe incollate, FONDALI E QUINTE:
I 71 disegni da restaurare si presentavano in precario stato di conservazione.
Da un punto di vista conservativo, le problematiche osservate sono imputabili
principalmente a danni di natura antropica dovute all’utilizzo del teatrino da parte di
bambini e da pregresse modalità di conservazione non idonee; con il tempo, tali
fattori si sono manifestati sulle opere con danni principalmente di natura fisica e
biologica.
TESTE IN CARTAPESTA ED INSERTI IN CARTA DELLE MARIONETTE:
Nella maggior parte dei casi il capo delle marionette presentava numerosi punti di rottura in corrispondenza delle giunture della testa, del collo, delle spalle e del foro di passaggio del filo di ferro. Gli inserti in carta impiegati per le rifiniture risultavano parzialmente distaccati dal vestito, lacerati e lacunosi.
In generale erano visibili evidenti depositi di polvere e depositi di natura eterogenea, inoltre la maggior parte delle marionette provviste di copricapo presentavano in corrispondenza della nuca o della fronte residui di colla di origine animale impiegata per il fissaggio dei cappelli alla testa delle marionette.
Infine, l’elevata complessità del manufatto, composto da numerosi elementi materici
dissimili tra loro, ha richiesto l’intervento corale di più professionalità qualificate al fine d’intervenire in maniera puntuale al recupero totale dell’opera.
particolare per gli abiti femminili con ampie gonne.
I filati metallici sono stati sottoposti a tampone con alcool a 98° per ridurre l’ossidazione e restituire lucentezza.
Una volta preparati i materiali idonei al restauro, tinti in nuances il più possibile simili agli originali, si è proceduto al consolidamento delle aree compromesse, sia quelle a vista (abiti esterni) che quelle interne (sottogonne, culottes femminili
ecc…), con attenzione particolare agli indumenti femminili in seta che, nelle lacune, hanno necessitato un riordino dei fili scomposti. Il consolidamento è stato effettuato a cucito ove possibile mentre dove il tessuto non ha permesso il passaggio dell’ago perché troppo disidratato e tendente a fratturarsi, è stato applicato dal retro un supporto in velo di seta trasparente, trattato con resina
termoadesiva ed applicato a caldo mediante termocauterio., La struttura lignea è stata smontata e la polvere superficiale è stata rimossa con pennelli e aspiratori dal legno a vista. All’interno degli incavi è stato necessario rimuovere con ferretti da dentista i depositi compattati, comprendenti anche frammenti di insetti. Il legno è stato pulito con spugne a suzione in PVA, inumidite.
Il retro e i bordi esterni del timpano sono stati verniciati in smalto azzurro; questa stesura non è originale. Presentava diversi strati di adesivo vinilico e frammenti di carta fotossidata, segno che un tempo si incollavano locandine o avvisi all’interno del frontone. L’adesivo vinilico è stato fatto rigonfiare con applicazioni di acqua calda in spugne a suzione in PVA, quindi scalzato con spatole a foglia d’olivo.
La stessa pratica è stata applicata sui residui di colle animali, mentre depositi di silicone, usati per far aderire delle viti, sono stati rimossi con le sole spatole.
Come trattamento antitarlo è stato approntato un sistema di assorbimento di vapori di permetrina in etere di petrolio, invece di un’applicazione direttamente su legno, per evitare interazioni con le parti in carta.
Le parti dipinte sono state depolverate molto leggermente con pennelli in nylon; la delicatezza delle superfici non ha permesso puliture tradizionali. Le abrasioni sono state corrette con acquarello e le gore di acqua e le tracce di pece sono state corrette a pastello. A pastello è stata ricostruita la base del proscenio, che è quindi molto delicata e non deve entrare mai a contatto diretto con le mani o con altre superfici, neanche a scopo protettivo.
Il sipario è stato liberato dal tondino di ferro e svincolato dal bastone, togliendo i chiodi e staccando delicatamente il lembo incollato con spatoline a foglia d’olivo; sul legno sono presenti frammenti della parte superiore della tela, probabilmente risalenti all’incollaggio originale.
Il sipario è stato riportato a una maggiore planarità, specie nella parte superiore, contestualmente alla messa in sicurezza della pellicola pittorica, avvenuta facendo riaderire le scaglie con una pasta d’amido di frumento. La presa è avvenuta sotto pesetti e si è operato per piccole zone localizzate.
Le toppe labili sono state staccate a spatolina; lacerazioni e mancanze di tela sono state risarcite con inserti in poliestere, fatti aderire con resina poliammide e termocauterio. La reintegrazione pittorica è stata eseguita con colori ad acquarello e le macchie scure e i fondi chiari sono stati risolti a pastello., FONDALI E QUINTE:
Dopo aver analizzato il materiale e individuato le problematiche principali, si è
proceduto con la rimozione a secco di depositi superficiali, eseguita con polvere di
gomma Staedtler, gomme Wishab e spugne in lattice Smoke-Off Sponge, in grado di captare il particolato atmosferico senza impartire sollecitazioni meccaniche sulla superficie del supporto.
Le lacune e le lacerazioni sono state risarcite con veli e carte giapponesi selezionati secondo la tipologia di fibre dell’impasto, la texture superficiale, la grammatura dei supporti originali. Il risarcimento è stato eseguito tramite l’adesione lungo i margini della lacuna di uno o due strati di carta e velo giapponese mediante etere di cellulosa. In generale, per il risarcimento delle lacune sono state impiegate le carte giapponesi Kami W8, W15, W 12 e Japico 632650, mentre per la chiusura di strappi e per il consolidamento superficiale delle zone abrase è stato impiegato il velo Tengujo 3,7 g/m2, in modo da effettuare un restauro resistente garantendone la massima trasparenza. Dopo il risarcimento delle lacune si è proceduto con l’integrazione cromatica dei restauri con acquerelli Winsor&Newton e matite colorate, al fine di garantire un buon livello di uniformità tra restauro e l’originale.
MARIONETTE:
L’intervento di restauro ha previsto una prima pulitura superficiale con pennelli a
setole morbide ed una aspirazione dei depositi polverulenti con microaspiratore museale Muntz. Le macchie di natura eterogenea sono state rimosse meccanicamente mediante bisturi e per tamponamento leggero con
soluzione idroalcolica (70% alcol e 30% acqua demineralizzata). Le fessurazioni a carico del capo, del collo e delle spalle sono state risarcite con carta giapponese (Kami W8) precedentemente tinta con acquerelli Winsor&Newton, ridotta in polpa con amido Zin Shofu e fatta aderire mediante spatole metalliche e pennelli.
Per quanto riguarda le divise in carta, i cappelli, i calzari e gli inserti sono stati
impiegati velo Tengujo 3,7 g/m2 e carta giapponese W12 e W11 precedentemente
tinta con acquerelli.
A conclusione dell’intervento si è proceduto l’integrazione cromatica delle parti
restaurate mediante acquerelli Winsor&Newton e matite colorate.