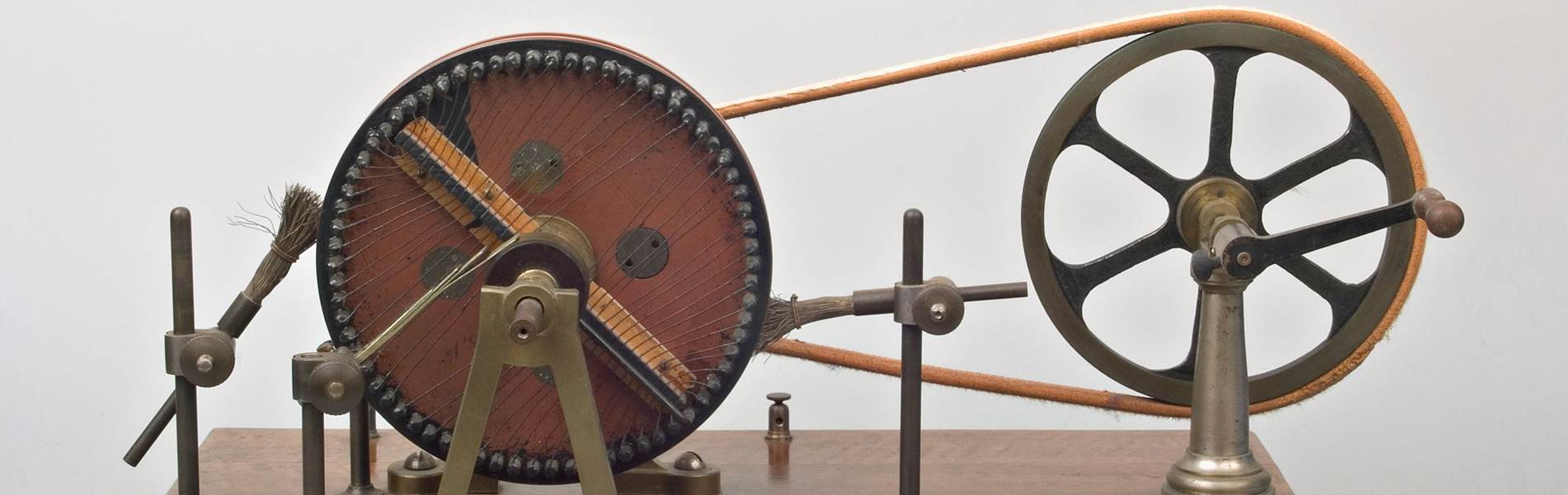Cimitero della Certosa di Ferrara






Ferrara (FE)
Negli anni successivi, durante il governo estense di Ercole I, Ferrara visse un periodo di profonde trasformazioni, prima fra tutte l’Addizione Erculea, grazie alla quale il monastero fu raccolto all’interno della cinta urbana. I lavori prevedevano anche la costruzione di una nuova chiesa dedicata a San Cristoforo, la cui paternità è attribuita allo stesso Biagio Rossetti, architetto di corte.
Per quasi tre secoli il complesso crebbe in prestigio e dimensioni. Tuttavia il suo destino fu profondamente segnato dalla soppressione napoleonica sul finire del XVIII secolo: con l’allontanamento della comunità monastica e la secolarizzazione degli edifici ecclesiastici, l’intero convento passò in ultimo alla gestione del Comune, che nel 1813 decise di adibirlo ufficialmente a cimitero cittadino.
La nuova destinazione cambia radicalmente il volto della Certosa: le parti fatiscenti e il vecchio luogo di culto vengono demoliti per fare spazio alle sepolture, mentre le celle monacali sono adattate a cappelle gentilizie. Nel 1830 l’architetto Ferdinando Canonici progetta un ampliamento che prevede il raddoppio dei chiostri e la costruzione di due corpi di fabbrica arricchiti da altrettanti porticati curvilinei. L’intervento mira a valorizzare e integrare la struttura esistente, costituita dalla chiesa rossettiana e dal Gran Claustro adiacente.
Ulteriori operazioni di restauro, proseguite fino agli anni Sessanta del XX secolo, hanno riparato i danni subìti durante la Seconda guerra mondiale, in particolare quelli dovuti al bombardamento del 28 gennaio 1944, che distrusse il campanile, l’abside, parte del transetto e numerose sepolture.
Oggi il camposanto si trova alla fine di via Borso, immerso nel verde dei parchi circostanti. I due grandi loggiati ricurvi in marmo e mattone abbracciano il giardino antistante, guidando idealmente lo sguardo verso il cuore del fabbricato: la chiesa di San Cristoforo. La facciata esterna, sobria e incompiuta, combina il cotto dei mattoni con l’opalino del marmo nel portale d’ingresso. Questa semplicità si riflette anche nella struttura interna, dove una sola navata scandita da sei cappelle laterali conduce alla zona presbiteriale e ai transetti. Il tempio custodisce tuttora opere di grande valore artistico, realizzate da maestri del Cinque e Seicento che rafforzano il patrimonio della capitale estense.
Adiacenti alla chiesa si trovano i due grandi chiostri laterali, noti come i Grandi Claustri. Il più antico, di origine estense, è un maestoso portico con volte a crociera e colonne a capitelli compositi; ospita nel loggiato il monumento del suo più illustre committente, il duca Borso d’Este. La sua tomba, che fino al 1815 era posizionata all’angolo con la chiesa, si trova adesso nell’esedra centrale, celebrata da un sarcofago pensile, parzialmente incassato e decorato da cornucopie e uccelli; nella parte alta, a ridosso delle mura, è possibile ammirare l’epigrafe e il ritratto del defunto colto di profilo.
A condividere gli ampi spazi della necropoli ferrarese si trovano le sepolture di personalità celebri, che hanno segnato la storia della città, tra cui il pittore Giovanni Boldini, l’insegnante Alda Costa, l’attrice Lyda Borelli e il figlio Giorgio Chini, il regista Michelangelo Antonioni e l’intellettuale umanistico Celio Calcagnini.