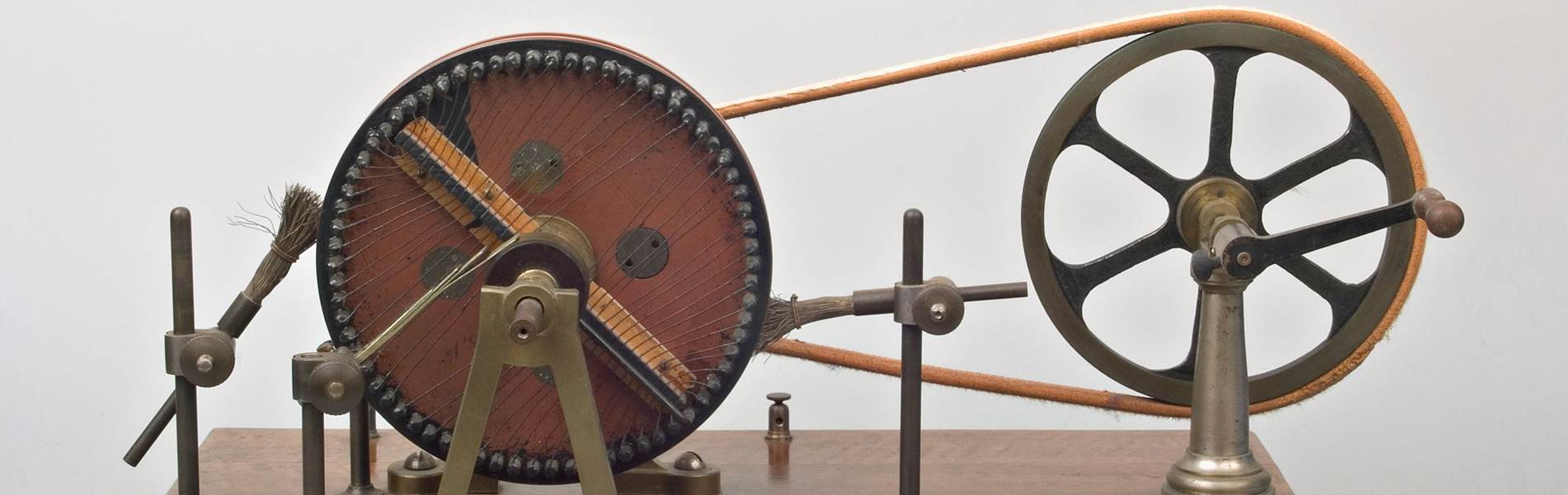Cimitero Monumentale di Reggio Emilia






Reggio Emilia (RE)
Il progetto iniziale del camposanto, opera dell’architetto urbanista Domenico Marchelli, rispondeva a molteplici esigenze di sanità pubblica: il nuovo sepolcreto doveva essere posto fuori dalle mura urbane, in un’area sicura, lontana da corsi d’acqua e ben esposta ai venti. Per questo la scelta del sito ricadde su una zona a sud-ovest della città, nei pressi di un vecchio cimitero presbiteriale, costruito appositamente nel 1631 per accogliere le vittime della peste.
Marchelli disegna un complesso semplice ma funzionale: un recinto porticato a pianta quadrata ospiterà sotto gli archi i sepolcri e al centro una piccola chiesa funebre, affiancata da due abitazioni per il cappellano e per gli addetti alla tumulazione. Presentato nel 1807, il progetto viene accettato con qualche modifica e l’anno successivo il cantiere è aperto. Tuttavia, nonostante l’approvazione, i lavori procedono a rilento, tanto che per qualche tempo si continua a usare il camposanto preesistente. Il complesso, anche a seguito di diverse interruzioni, viene finalmente completato nel 1818 sotto la guida del suo ideatore, con la realizzazione della cappella cimiteriale e del portico.
Già sul finire degli anni Trenta il cimitero inizia a dimostrarsi insufficiente rispetto alla crescita demografica della popolazione, tanto che tra gli anni ’40 e ’60 del XIX secolo si procede con vari ampliamenti soprattutto verso est, modificando l’originario schema quadrato a favore di una pianta rettangolare più ampia. È proprio in questo periodo che la concezione stilistica del fabbricato cambia e l’architettura neoclassica, con il suo simbolismo cosmico, cede il passo a un gusto più borghese che utilizza i monumenti funebri come espressione delle gerarchie sociali. Le famiglie ricche iniziano a erigere edicole private e monumenti personalizzati, spesso in concessione perpetua, trasformando l’interno del sepolcreto in una sorta di esposizione di stili architettonici differenti.
Durante il periodo fascista il camposanto viene ulteriormente trasformato: il piano regolatore del 1936 lo colloca al centro di nuove arterie viarie, sancendo il suo ruolo di monumento urbano. Tuttavia, nonostante i continui ampliamenti, la questione della capienza resta aperta e solo nel 1971 l’individuazione di una nuova area a Coviolo consente di costruire un nuovo sito cimiteriale.
Le tortuose vicende costruttive del Cimitero Suburbano di Reggio Emilia l’hanno portato ad arricchirsi degli esiti artistici prodotti in oltre un secolo di storia. Al suo interno si possono trovare: gli affreschi e i mosaici creati da Anselmo Govi per la facciata d’ingresso; la chiesa neoclassica dedicata ai santi Grisante e Daria, unico esempio di questo stile in città; il reticolo dei portici che, nella loro imprevedibilità esecutiva, testimoniano le diverse fasi di espansione. Fra gli altri contributi, a rendere immenso il patrimonio di questo sito sono soprattutto le splendide opere funerarie di artisti come Carmela Adani, Paolo Aleotti, Ilario Bedotti, Guglielmo Fornaciari, Enrico Franzini, Tonino Grassi, Ferruccio Orlandini, Riccardo Secchi e Ciro Zironi, i quali hanno trasformato questo luogo della memoria nella dimora dei loro capolavori.