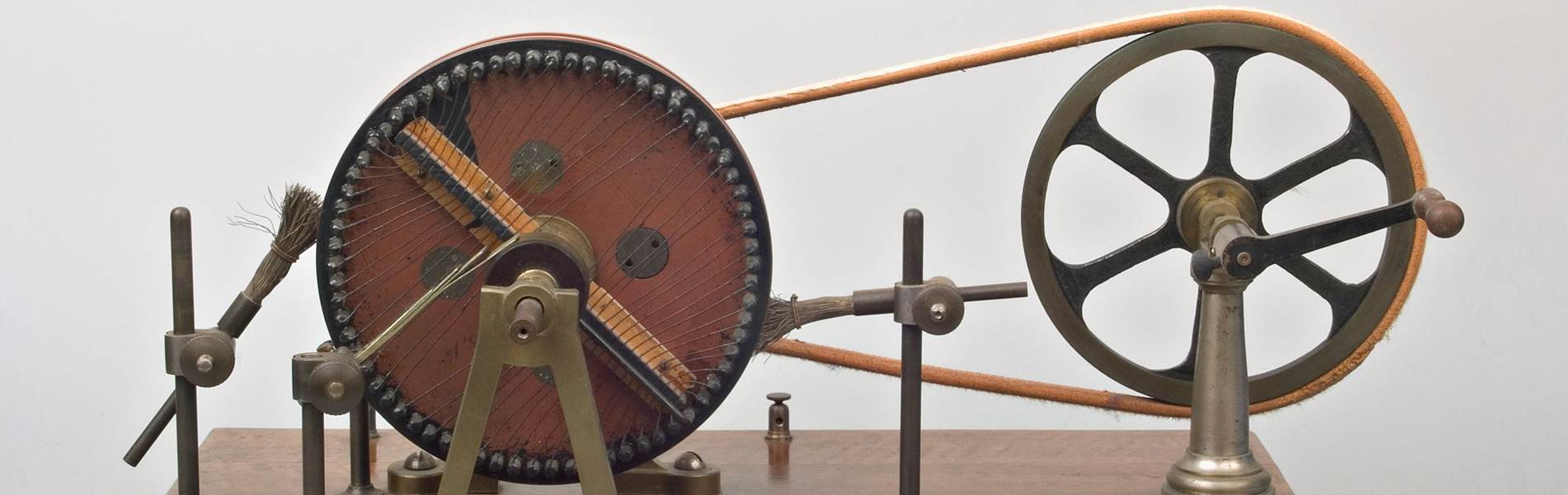loc. Sorrivoli
Roncofreddo (FC)
Sorrivoli malatestiana
Nel 1278 il papa ottenne dopo un lungo conflitto il riconoscimento imperiale dei suoi diritti della Romagna. Nel corso del Trecento i Malatesta, dal 1295 signori di Rimini, cercarono però di espandersi a nord-ovest dei loro domini, manifestando anche nel Cesenate quelle ambizioni espansionistiche che a sud li portarono a insidiare il dominio della Chiesa nelle Marche.
Ottenuto il vicariato apostolico di Rimini e di alcune città marchigiane grazie alla loro sottomissione al papa, e recuperata alla Chiesa nel 1357 Cesena che era stata occupata dai signori ribelli di Forlì, vent’anni dopo i Malatesta si assicurarono definitivamente il dominio della città, ampliando in breve i loro domini anche nel suo territorio, dal mare alle colline.
Strappato all’arcivescovo ravennate nel 1392, il castrum di Sorrivoli venne rafforzato dai nuovi signori, che eressero sul punto più elevato del colle una torre quadrata in arenaria e mattoni, affiancata da edifici di servizio. Nella prima metà del secolo successivo i Malatesta ottennero dal papa il vicariato di Sorrivoli con altri castelli arcivescovili.
L’apparato difensivo fu quindi sottoposto a ulteriori interventi che lo trasformarono in una vera rocca, integrando le strutture esistenti con un fossato e quattro torri angolari raccordate da mura atte all’impiego delle armi da fuoco, secondo un modello applicato anche in altre fortificazioni del casato.
I Roverella, conti di Sorrivoli
Spartiti i possessi cesenati e riminesi tra i due rami dei Malatesta, nel 1448 i signori di Cesena, per garantirsi la benevolenza della Chiesa ravennate, decisero di restituirle Sorrivoli in cambio di alcuni possedimenti a Longiano.
Quarant’anni dopo l’arcivescovo Filasio infeudò Sorrivoli con Monteleone alla sua famiglia, i Roverella, inaugurando una signoria che sarebbe durata ben tre secoli. Già all’inizio del Cinquecento però la rocca – allora residenza dell’arcivescovo – venne occupata da Cesare Borgia entrando per breve tempo a far parte dell’effimero Ducato di Romagna con capitale Cesena, creato per il condottiero dal padre, papa Alessandro.
Caduto il Borgia, e recuperati definitivamente tutti i territori romagnoli con la vittoria su Venezia, il nuovo papa Giulio II li annesse direttamente nella compagine statale, cancellando il sistema dei vicariati signorili e concedendo singoli feudi a famiglie di provata fedeltà.
I Roverella poterono così tornare a Sorrivoli e Monteleone, ottenendo nel 1527 la contea, mentre Roncofreddo veniva assegnata con Montiano prima agli Zampeschi poi ai Malatesta di Sogliano. I neo-conti provvidero ad ampliare la rocca e adeguarla alle nuove tecniche militari imperniate sull’artiglieria pesante, inserendo nella struttura muraria una grande baluardo ad asso di picche, puntato verso l’accesso al castello e dotato di feritoie alla francese, che inglobò una delle torri preesistenti.
Da rocca a palazzo
A partire dalla seconda metà del Cinquecento le ormai obsolete fortificazioni romagnole vennero riconvertite a nuovi usi, residenziali o carcerari, quando non lasciate andare in rovina.
Nel corso del secolo successivo la rocca di Sorrivoli fu così sottoposta a una serie di interventi strutturali tesi a valorizzarne le funzioni residenziali che la trasformarono in una residenza di campagna, con la realizzazione di un alto edificio rettangolare al posto della cortina muraria a settentrione, l’innalzamento di una torre d’angolo e l’inserimento nel mastio di una porta di accesso al palazzo.
I restauri settecenteschi del complesso mirarono a loro volta a garantire maggior sostegno agli ambienti destinati ad abitazione, con un significativo inspessimento delle mura e la costruzione di un ponte in muratura al posto di quello levatoio.
Dalla fine del feudo alla valorizzazione
Dopo la parentesi napoleonica, durante la quale avevano continuato a risiedere nel castello come privati cittadini, i Roverella riebbero il feudo - senza Monteleone andato nel frattempo ai Guìccioli - che mantennero fino al 1858, quando il casato si estinse.
L’edificio fu acquistato dalla famiglia Allocatelli, poi Allocatelli Fabbri, che dopo la seconda guerra mondiale lo donò alla parrocchia, per insediarvi la nuova chiesa dedicata a Sant’Aldebrando, in sostituzione di quella di San Lorenzo resa inagibile dai bombardamenti. Nel palazzo trovarono spazio la chiesa e alcuni ambienti accessori, mentre la torre fu trasformata in campanile.
Restaurato come il borgo circostante tra il Novecento e gli anni Duemila, l’edificio, oggi sede della parrocchia e di associazioni culturali e ricreative, ospita anche eventi e rassegne come il Festival Internazionale dei Burattini.
Uno studio della storia costruttiva del castello è stato realizzato nel 2011 dall’Università di Bologna nell’ambito del progetto di schedatura dei castelli emiliano-romagnoli promosso dalla stessa università con l’Istituto beni culturali della Regione Emilia-Romagna; studio che ha consentito anche interessanti confronti tra la rocca di Sorrivoli, Monteleone e altre rocche malatestiane presenti nella zona tra Cesena e Rimini.
VISITA
Dominante sul borgo che circonda l’antico fossato, la rocca a pianta quadrangolare mantiene intatte le sue strutture principali: le mura bastionate, la struttura del ponte levatoio, il mastio e il palazzo residenziale; pochi tratti rimangono invece dell’ulteriore cinta di mura esterna alla rocca.
Si accede al complesso attraverso le due porte aperte nelle mura o da una scalinata che dalla strada principale giunge all’ingresso attraverso un ponticello in muratura che ha sostituito quello levatoio, di cui rimangono visibili i fori degli ingranaggi.
Le mura esterne ad asso di picche hanno lunghe facciate rettilinee con orecchioni e fianchi arretrati e sono sormontate da tre torri angolari, mentre la quarta è inglobata nel bastione a punta dotato di feritoie per le bombardiere.
L’ampia corte interna è dominata dal possente mastio a pianta quadrata in arenaria e mattoni; due lunghi edifici ospitano la chiesa e le attività culturali e ricreative, un terzo è oggi scomparso. Insieme alla corte, dalla quale si ammira il panorama sulle colline circostanti, è possibile visitare liberamente i vasti sotterranei con coperture a volta, un tempo utilizzati come scuderie; la visita agli ambienti interni degli edifici va richiesta ai gestori delle attività qui ospitate.
Ambiti territoriali presidiati dal castello:
valle RubiconeSignori del castello tra medioevo e età moderna:
Malatesta,Roverella
AA.VV., Rocche e Castelli di Romagna, III voll, Bologna, Alfa, 1970-1972, rist.an. Imola, 1999-2001
Augenti A, Cirelli E., Fiorini A., Ravaioli E., L’incastellamento in Romagna: indagini 2006-2008, in V Congresso di Archeologia Medievale, a cura di G. Volpe, P. Favia (Manfredonia-Foggia 2009), Firenze, pp. 341-348
Augenti A., Cirelli E., Fiorini A., Ravaioli E., Insediamenti e organizzazione del territorio in Romagna (secoli X-XIV), Archeologia Medievale, XXXVII, 2010
A.Fiorini, Dal castrum altomedievale al restauro settecentesco: storia e archeologia del castello di Sorrivoli (Roncofreddo - FC), Arqueología de la arquitectura, cpy 2011 Andrea Fiorini https://www.academia.edu/1431693/Dal_castrum_altomedievale_al_restauro_settecentesco_storia_e_archeologia_del_castello_di_Sorrivoli_Roncofreddo_-_FC_
B. Vernia, Roncofreddo - Castello di Sorrivoli, http://www.emiliaromagna.beniculturali.it/index.php?it/108/ricerca-itinerari/18/322
G. Bolognesi, E. Lorenzini, Storia di Sorrivoli, Associazione Culturale "IL CASTELLO", Cesenatico, Sicograf, 2004