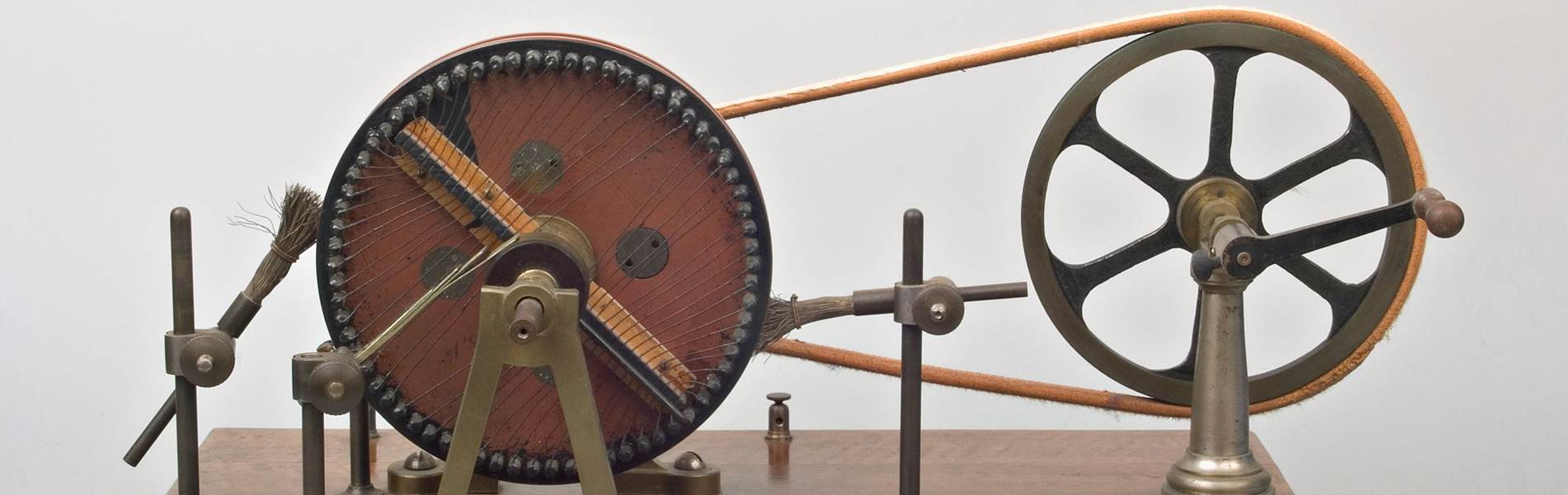Musei del Castello di Bardi

Terrecotte
Ceramiche
Attrezzi da lavoro
Arredi e mobilia
Attrezzi e mezzi agricoli
Diorami
Materiale documentario
Via Castello, 1
Bardi (PR)
Archeologia preistorica/paletnologia
Archeologia protostorica
Archeologia classica
Archeologia medievale
Arti e tradizioni popolari
Etnologia/Etnografia
Tematico
Il secondo tema affrontato dal museo è quello del sito di Groppo Predellara a Rocca di Varsi, luogo arroccato e naturalmente difeso, più volte frequentato nel corso dei secoli a partire dal Palelitico sino al Medioevo. Fra le testimonianze registrate in questa località spicca l’abitato su altura qui impiantato agli inizi della media età del Bronzo (1650 a.C.) e poi parzialmente dislocato un paio di secoli dopo a causa di problemi di instabilità determinati da un terremoto. I materiali ceramici restituiti dal villaggio documentano evidenti influenze da parte della coeva cultura terramaricola, sviluppatasi nei grandi villaggi di pianura.
Istituito dall'Associazione Studi e Ricerche dell'Alta Val Ceno, è ubicato nei quartieri già destinati agli alloggi delle guardie e documenta le arti e i mestieri praticati nella vallata. Gli oggetti inseriti nel percorso espositivo sono distribuiti in prevalenza con un criterio di rievocazione ambientale; si tratta in gran parte di suppellettili e attrezzature relative al lavoro e alla vita quotidiana, alla pastorizia, alle attività boschive, all'allevamento e all'agricoltura. L’itinerario è arricchito da una esposizione permanente di macchine da guerra medievali ricostruite a grandezza naturale e funzionanti.
Ciascuno dei sette ambienti museali propone uno spaccato specifico della vita quotidiana dell'epoca preindustriale. Le stanze nella parte a sinistra del salone centrale sono riservate al mondo del lavoro. La prima è dedicata alla figura dell'artigiano domestico, con gli oggetti necessari alla manutenzione dell'abitazione e gli attrezzi da lavoro; nell'ambiente successivo si incontrano figure tipiche dell'artigianato montano: il falegname, il sarto, il ciabattino. Tutte sono strettamente connesse all'economia del bosco e della pastorizia: oltre al vestiario, con i loro poveri strumenti questi artefici provvedevano a fornire agli abitanti la maggioranza degli oggetti di lavoro e d'uso comune. Alle figure del carraio e del maniscalco e dello scalpellino, il cui lavoro coadiuvava indirettamente la comunicazione della valle verso l'esterno, sono riservate le ultime due stanze. Il lato destro (a ovest) è invece dedicato al mondo domestico. La cospicua raccolta di oggetti ha permesso la ricostruzione, con elementi originali, delle due stanze che componevano l'abitazione rurale: la cucina e la camera da letto.
Il Museo della fauna e del bracconaggio documenta attraverso reperti e diorami la storia e gli attrezzi utilizzati nel bracconaggio e nel trappolaggio lungo i secoli e in più continenti. In relazione al fenomeno del bracconaggio, che ebbe inizio in Europa nel IX-X d. C., si espone una serie di trappole o di loro ricostruzioni utilizzate dall'antichità fino ad oggi. Per meglio documentare espedienti e meccanismi utilizzati nella cattura di varie specie animali, si fa ricorso a numerosi diorami a grandezza naturale e ad altri in scala.
Principale obiettivo museale è quello di spiegare l'antico significato che tale attività illegale ha avuto nella vita delle popolazioni montane e al tempo stesso illustrare i principali aspetti di protezione della fauna e dell'ambiente.
Il percorso si articola in vetrine-diorami che ripropongono porzioni di ambiente naturale con gli esemplari imbalsamati delle specie oggetto di bracconaggio (tra cui il lupo, la poiana, lo sparviero) e gli attrezzi per la cattura. Ogni vetrina è affiancata da pannelli a scopo didattico che illustrano la biologia degli animali e le particolarità del loro ambiente naturale. Di sicuro interesse è la sezione dedicata alla legge Cites (che regola il commercio e la detenzione di specie rare o in pericolo di estinzione) dove vengono mostrati in modo organico oggetti ricavati da specie protette