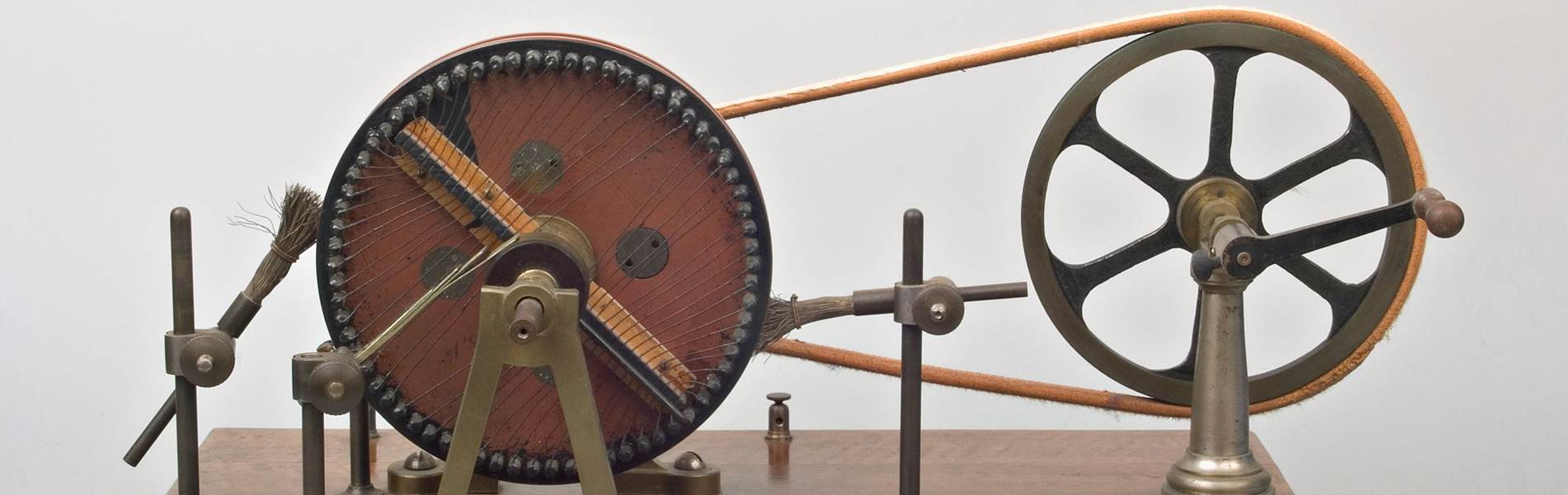tavola/ pittura a olio
sec. XVI (1548 - 1548)
Il dipinto è stato restaurato nel 1977-78 da Ottorino Nonfarmale, in quell'occasione, a causa dell'irrimediabile stato di conservazione della tavola il dipinto è stato trasportato su di un nuovo supporto. La pulitura ha evidenziato alcune lacune, disposte verticalmente in corrispondenza delle assi, lasciate a vista ed integrate tonalmente. In precedenza vi era stato un restauro nel 1779 a cura del pittore padovano Francesco Zannoni, di cui però non esiste una documentazione analitica. Del 1885 è l'intervento di Venceslao Bigoni che procedette alla pulitura e al consolidamento del colore,tentò inoltre di correggere gli anomali movimenti di curvatura del legno tramite il rinforzo di spranghe orizzontali. Infine, nel 1947, Dante De Carolis intervenne sui lievi danni provocati dagli eventi bellici.
Nell'autobiografia del Vasari troviamo notizie sulla committenza del dipinto: dal ricordo n. 170 apprendiamo che l'aretino si trovava a Rimini nell'ottobre 1547 per eseguire L'Adorazione dei Magi nella Chiesa di Santa Maria di Scolca. Ricevuta da Carlo Marcheselli la commissione dell'Estasi di San Francesco per la chiesa omonima, si recò a Ravenna il 15 gennaio 1548 per concordare con l'Abate di Classe e padre Romualdo da Verona i termini del contratto per la Deposizione. Alla fine di marzo dello stesso anno Vasari era a Ravenna per dedicarsi alla commissione dei Camaldolesi. Nei registri del Monastero di Sant'Apollinare è segnato un pagamento in data 23 giugno 1548. Come riporta Vasari stesso la cornice è opera di Giuliano di Baccio d'Agnolo e presenta un motivo di foglie d'acanto aggettanti contro un fondo azzurro scuro, racchiuso tra un giro di ovuli e un festone di frutti e foglie intrecciati che percorre senza interruzione il bordo interno.
Secondo le fonti l'opera fu collocata in un primo momento nel coro della Chiesa di San Bartolomeo "in turricula", attigua al nuovo fabbricato dell'abbazia classense e riconsacrata dai monaci con il nome di San Romualdo, edificio demolito nel 1629. Quando venne edificata la nuova chiesa (1630-37) il dipinto venne trasportato nelle stanze abbaziali "a cagione dell'umido" (Beltrami 1783) o forse perchè non si confaceva più alla nuova architettura. In questa sede rimase anche dopo la soppressione del monastero (1798), fino all'istituzione dell'Accademia di Belle Arti e della sua Galleria alla quale pervenne nel 1829.
Un disegno del Louvre (inv. 2095), probabilmente opera di Cristofano Gherardi (Monbeig Goguel, 1972) si connette strettamente con il dipinto e prima ancora con la Pietà eseguita nel 1542 per Bindo Altoviti. In contrasto con la testimonianza del Vasari che afferma che il Gherardi arrivò a Ravenna quando sia l'opera ravennate che quella riminese erano state terminate, Ferdinando Bologna (1959) ipotizza un importante coinvolgimento del collaboratore, mentre Paola Barocchi tende a limitarne l'intervento alle parti in secondo piano. Gli ultimi studi non paiono convalidare questa ipotesi, ma vedono in Prospero Fontana (Pasini 1982 e 1998 e Fortunati (1986) il principale collaboratore dell'aretino in questa opera. La composizione ravennate riscosse molto successo in ambiente romagnolo, costituì infatti il modello per numerosi dipinti, tra i quali si ricordano la Deposizione di Giulio Ponteghini e quella di Francesco Menzocchi nella Pinacoteca di Forlì, nonchè la Deposizione di Pierpaolo Menzocchi all'Istituto Prati di Forlì e quella di Giovanni Battista Ragazzini a Fratte Rosa.