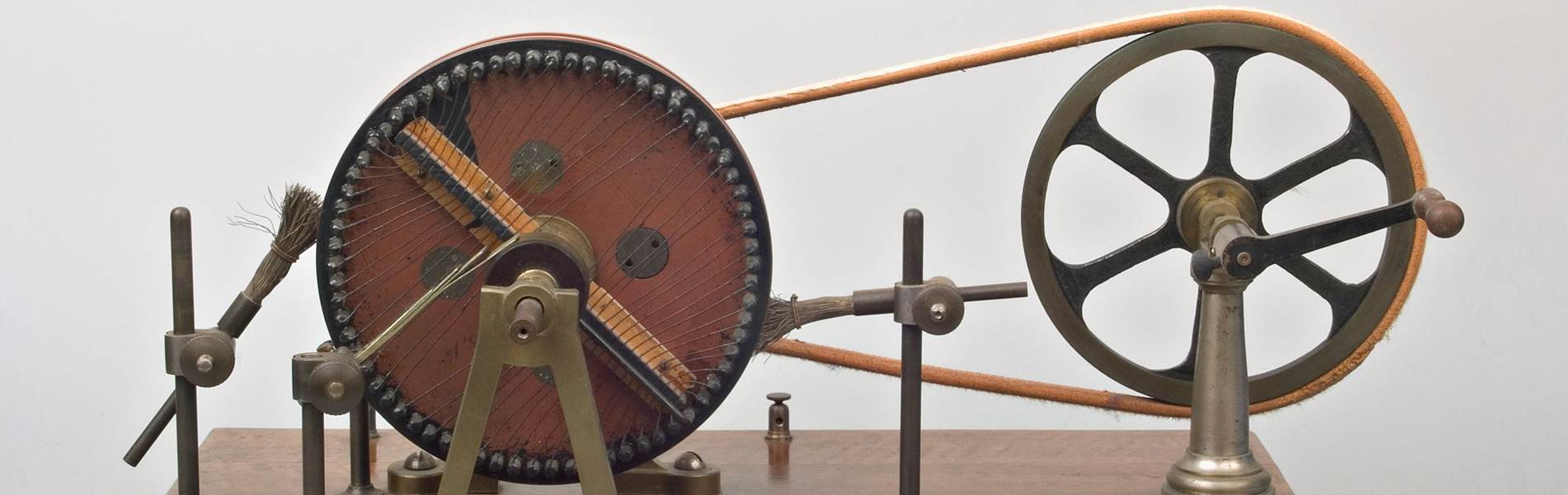tela/ pittura a olio
diametro con cornice 98
sec. XVIII (1735 - 1740)
La teletta circolare che rappresenta l'ascesa di Psiche all'Olimpo altro non è che il bozzetto del soffitto di Palazzo Colonna a Roma realizzato da Francesco Mancini. L'opera è forse pervenuta alla Classense al seguito del Card. Nicolò Colonna (1730-1795) Legato a Ravenna fino alla sua morte. Si deve alle pagine di una studiosa insigne quale Berti Toesca, la descrizione mirabile di Palazzo Colonna a Roma e dei suoi ambienti (cfr. Berti Toesca 1943, p. 7) come, per restare aderenti al nostro dipinto, quello del salone superiore, ove è affrescata l'ascesa di Psiche. Niccolò Michetti, l'architetto romano che progettò l'edificio ed i suoi scenografici interni, si esaltò particolarmente nella realizzazione del salone superiore ove, tra i decori a stucco, sbocciano leggeri delle pareti splendidi bassorilievi ellenistici e stucchi classicheggianti. Nicchioni si aprono sulla trabeazione, di cui alcuni ornati secondo la moda "rocaille", e su questi sono lievi affreschi di lunette che rappresentano amorini che si rincorrono con gli emblemi della Virtù. I pennacchi accolgono monocromi con le fatiche di Psiche, mentre la stessa trionfa nel soffitto cupuliforme laddove ascende al cielo con Mercurio. Berti Toesca riconosce qui la mano di Francesco Mancini, - che dunque collaborò a fondo con Michetti con esiti veramente notevoli - artista nato a Sant'Angelo in Vado nel 1769 e attivo a Roma forse già prima del 1720, membro dell'Accademia di San Luca nel 1725 e principe della stessa nel 1750-51. Allievo di Cignani, del quale tuttavia conservava solo una superficiale influenza correggesca, rimase folgorato a Roma dai virtusi del Barocco, quali Pietro da Cortona e Baciccio, oltreché dalle figure e dalla luci trasparenti che ridondavano dai soffitti delle chiese. Va ricordato che egli è l'autore del Carro del Sole in Palazzo Albicini a Forlì e delle due grandi tele (schede nctn 00000027 00000028) e dell'affresco della Biblioteca di Classe e che realizzò numerose opere decorative, soprattutto nell'Italia centrale: Cattedrale di Foligno, Chiesa dei Filippinia Perugia, Chiesa della Misericordia a Macerata. Tuttavia il suo capolavoro è il Miracolo di San Pietro al Quirinale. Nei suoi lavori egli oscilla fra la levità dei colori presente negli affreschi, e una calda pastosità delle tinte più propria ai lavori da cavalletto. Per via di una forte analogia stilistica con la Incoronazione di Macerata del 1736, Berti Toesca fa risalire la decorazione di Palazzo Colonna da parte di Mancini agli anni compresi fra il 1735 ed 1l 1740. G. Sestieri pubblica la teletta circolare che costituisce il bozzetto del soffitto di Palazzo Colonna nel 1977. L'opera, che è sporca e presenta lacerazioni e perdite di colore, rivela, soprattutto nella leggerezza del ductus lineare libero e tuttavia sempre controllato, un accostamento con M.A. Franceschini, anch'egli allievo di Cignani e presente, di quanto in quanto, a Roma. Sia l'affresco che il suo bozzetto esplicitano una chiarezza d'intenti: sono pitture vere che peraltro riecheggiano la composizione dell'Assunta, sempre nella chiesa della Madonna della Misericordia di Macerata. Berti Toesca esalta, nello scritto già citato, l'opera di Mancini, a cominciare dalla scelta del tema di Psiche, passando per la levità con cui tratta tutto il complesso decorativo, caratterizzato anche dalle finte architetture oltreché dallo sfondato della rappresentazione vera e propria. Ne apprezza il cromatismo delicato unito ad una felicità di disegno non comune (anche se non sempre la composizione è mirabile), insomma: Mancini fu vero pittore, con una propria cifra stilistica grazie alla quale creò bei giochi di "nuvole grigie ed argentine che accarezzano, sostengono, nascondono i corpi divini e angelici dei suoi Paradisi e dei suoi Olimpi"; possedeva inoltre una propria gamma coloristica di tutto rispetto. Nel rappresentare il sorriso attonito dei suoi angeli rivela il richiamo al Correggio, così come nella morbidezza delle carni dei suoi Amorini. Dipingeva in sostanza con dolcezza come si può evincere dalle rappresentazioni di Giove, di Psiche stessa e di Cupido che sembra un San Giovannino. E' la calma che trionfa in quest'opera da cui sono escluse tutte le paturnie della vita, tutti i dolori e tutte le commozioni: "lieto e graditissimo pittore per i suoi contemporanei: piacevole, leggero e grazioso per noi, anche se a volte un po' troppo inzuccherato".