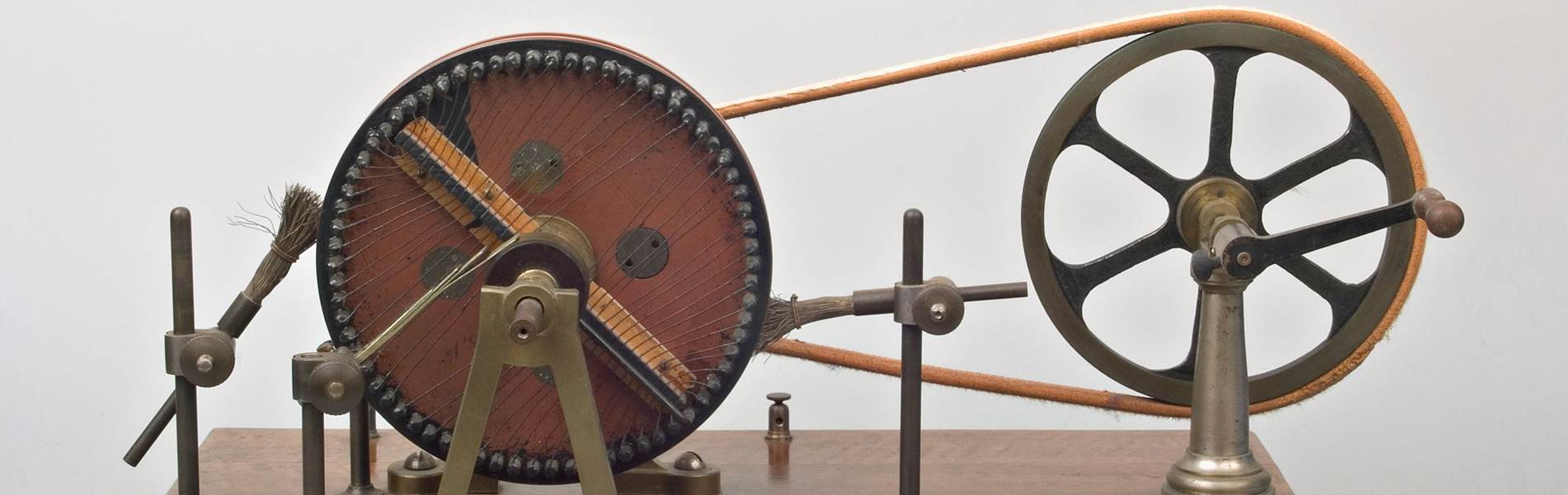Cerca e cavatura del tartufo - UNESCO




Il progetto “Patrimonio UNESCO in Emilia-Romagna” nasce dalla profonda vocazione della Regione a preservare e valorizzare il proprio patrimonio culturale e naturale e la sua unicità. L’obiettivo è offrire un punto di accesso privilegiato ai temi del Patrimonio Mondiale e all’universo dei riconoscimenti UNESCO presenti sul territorio, creando strumenti di conoscenza, approfondimento e promozione. Ogni sito viene presentato all’interno del portale PatER attraverso schede che ne raccontano l’Eccezionale Valore Universale, i riconoscimenti ricevuti, gli aspetti storici, artistici, culturali e naturalistici e le relazioni con altri beni collegati nel Catalogo regionale del patrimonio.
Oltre ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, l’UNESCO annovera beni e tradizioni riconosciuti come Patrimonio Culturale Immateriale, inseriti nel programma “Memoria del Mondo” e nei luoghi “Messaggeri di una cultura di Pace”, a testimonianza della pluralità e ricchezza di espressioni culturali che caratterizzano l’Emilia-Romagna.
In questo quadro si inserisce la Legge nazionale n. 77 del 2006, che prevede misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, rafforzando l’impegno dello Stato e delle Regioni nella loro salvaguardia e valorizzazione. Fondamentale riferimento è la “Convenzione del Patrimonio Mondiale” del 1972, che impegna gli stati membri a proteggere i beni culturali e naturali riconosciuti come patrimonio dell’umanità, per trasmettere alle generazioni future un’eredità fragile e preziosa, la cui scomparsa provocherebbe la perdita di una testimonianza unica e universale, appartenente a tutti i popoli.
Raccontando e connettendo i propri siti UNESCO all’interno del Catalogo regionale del patrimonio culturale, la Regione favorisce la diffusione della loro conoscenza e rafforza, nella coscienza collettiva, la necessità vitale di tutelarli e valorizzarli.
Patrimonio culturale immateriale UNESCO